Alice nel Paese delle Meraviglie e il riflesso vittoriano
Quando nel 1865 Lewis Carroll pubblica Alice nel Paese delle Meraviglie (titolo originale: Alice’s Adventures in Wonderland), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda si trova nel pieno dell’epoca vittoriana, un periodo di grandi trasformazioni sociali, scientifiche e culturali. Dietro il velo del nonsense e dei giochi linguistici, il viaggio surreale di Alice nel Paese delle Meraviglie riflette in modo ironico, e spesso paradossale, molte delle contraddizioni e delle convenzioni del tempo. Ma cosa ci racconta davvero questo racconto fantastico sul mondo vittoriano? E quanto l’universo bizzarro di Carroll è figlio del periodo in cui è nato?
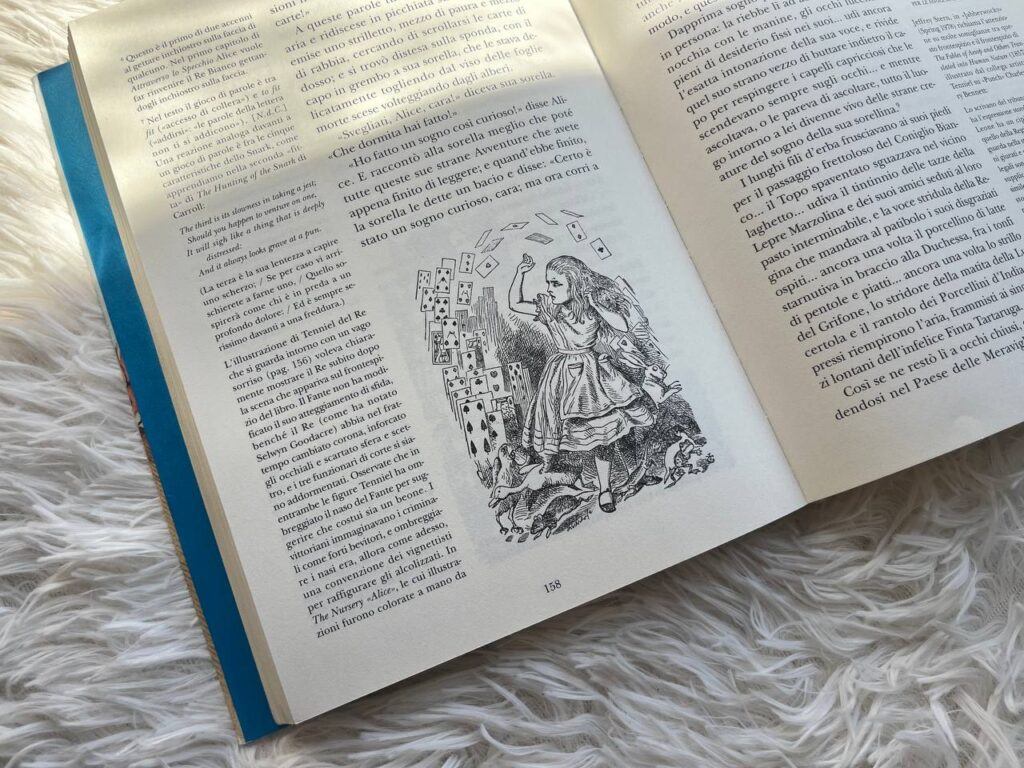
In un’epoca dominata da rigide norme morali, da una visione gerarchica della società e da un crescente fervore scientifico, l’opera di Carroll si presenta come una brillante anomalia: un mondo al contrario, dove la logica si capovolge, l’autorità viene derisa e il linguaggio si trasforma in un gioco disorientante. Non è un caso che il personaggio di Alice, una bambina curiosa e indipendente, si trovi spesso a scontrarsi con figure grottesche di potere, regole incomprensibili e situazioni illogiche. Carroll sembra usare l’assurdo per interrogare e smascherare il razionalismo vittoriano. L’opera si configura anche come il frutto di una nuova attenzione per l’infanzia, che proprio nel XIX secolo inizia a essere considerata non più soltanto come una “preparazione all’età adulta”, ma come una fase della vita dotata di dignità propria. Carroll costruisce un universo che sfida le categorie rigide del sapere adulto, dando spazio al pensiero libero, al gioco e alla fantasia.
Il periodo in cui visse Lewis Carroll può essere definito un’“Inghilterra di mutazioni”, travolta dalle prime due Rivoluzioni Industriali che portarono profondi cambiamenti a livello sociale, politico ed economico. Il 28 giugno 1838, alla morte di re Guglielmo IV, salì al trono la nipote diciottenne Alessandrina Vittoria, che sarebbe diventata la regina Vittoria:
“Vittoria diventa così “per grazia di Dio, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda, difensore della fede”1.
Fu un’epoca di progresso tecnico e scientifico senza precedenti: la rivoluzione industriale trasformò radicalmente la società inglese, le città si ingrandirono, le ferrovie unirono il paese e l’Impero britannico raggiunse la sua massima estensione. L’apice di questo cambiamento fu rappresentato dalla costruzione del Crystal Palace, progettato da Joseph Paxton per la Grande Esposizione di Londra del 1851 (Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations), simbolo della fiducia vittoriana nella superiorità del presente sul passato:
“Per la prima volta nella storia il palazzo di cristallo doveva accogliere, da tutto il mondo, i prodotti più perfetti dell’ingegno umano, comprese le opere d’arte, e diventare uno specchio del progresso umano. Nella storia dell’umanità esso segna, in un certo senso, l’ingresso nell’età della scienza e della tecnica, nella piena e visibile consapevolezza della superiorità del presente sul passato”2.
La Grande Esposizione contò migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo: l’Inghilterra si presentava come esempio del progresso tecnologico per tutti gli Stati partecipanti. A partire da qui cominciò a prevalere e a diffondersi una concezione diversa del lavoro e della vita; la “produzione” prese il sopravvento sul resto: sulle persone, sui sentimenti, sugli interessi e sui bisogni degli individui. Con questo fervore tecnologico e produttivo, cambiò anche la concezione del lavoro e della vita: la macchina dettava i ritmi, e la produzione prendeva il sopravvento sulle persone, sui sentimenti e sui bisogni. Thomas Carlyle definì questo periodo l’“Età Meccanica” (“Mechanical Age”)3, l’epoca dei macchinari.
Nella Londra di metà Ottocento convivevano realtà sociali molto diverse tra loro. L’espansione industriale, che trasformò la città in una metropoli moderna, mise in evidenza la netta separazione tra i luoghi di lavoro – fabbriche, officine, magazzini – e le zone residenziali. Questa divisione urbanistica accentuò i contrasti tra i quartieri eleganti della borghesia e le aree popolari, spesso segnate da miseria e sovraffollamento. In questo contesto si sviluppò un’educazione infantile improntata alla razionalità, all’obbedienza e all’utilitarismo, tutti tratti che emergono chiaramente in Alice nel Paese delle Meraviglie.
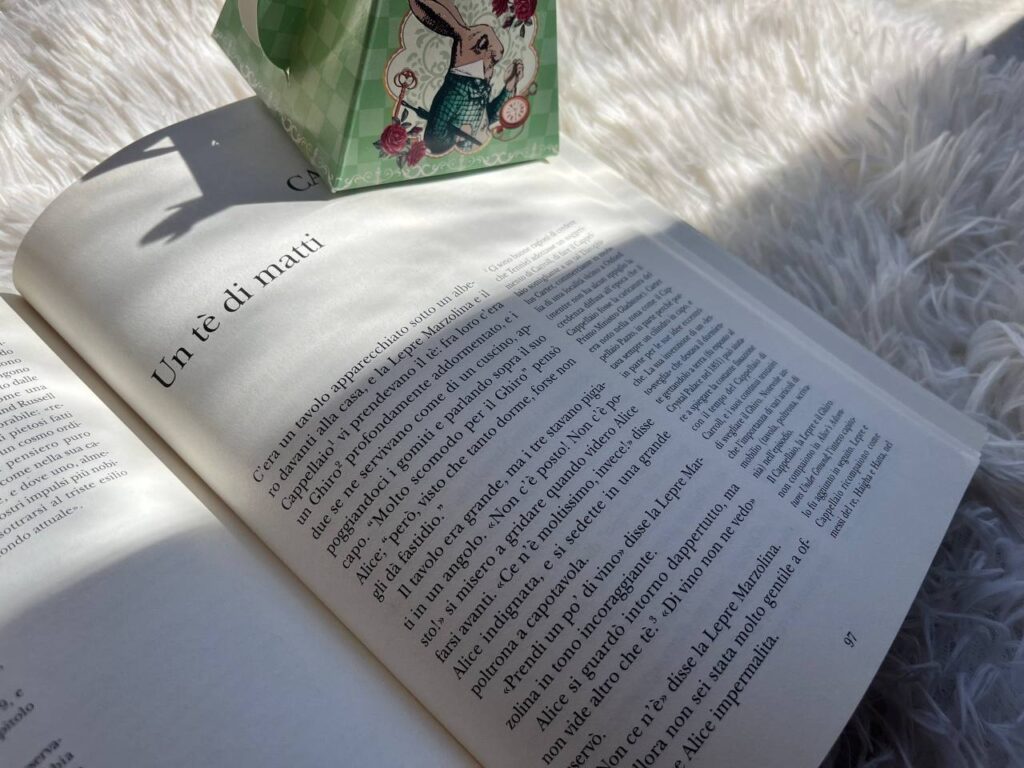
In Alice si ritrovano perfettamente le influenze che i tratti distintivi della società vittoriana esercitarono sull’educazione dei bambini cresciuti in quel contesto storico. La razionalità, il senso del dovere e l’utilitarismo emergono nel suo comportamento anche nei mondi immaginari in cui vive le sue avventure:
Alice, dunque, incarna la tipica figura della bambina vittoriana beneducata e borghese: costantemente preoccupata per la qualità della vita ed i principi della buona educazione4.
È proprio nel Paese delle Meraviglie, tuttavia, che appare evidente la sua difficoltà a distaccarsi da un mondo regolato da norme rigide e logiche soffocanti. Nonostante l’assurdità e l’imprevedibilità degli ambienti fantastici che attraversa, Alice continua a riflettere le caratteristiche più profonde della mentalità vittoriana, rivelando così quanto sia radicata in lei l’educazione ricevuta:
“Alice deve adattarsi a un mondo senza leggi; al di là dello Specchio, a un mondo governato da leggi a cui non è abituata. Deve imparare, per esempio, ad allontanarsi da un luogo per poterlo raggiungere, o a scappare velocemente per rimanere dov’è. Nel Paese delle Meraviglie, Alice è l’unica persona dotata di autocontrollo; nel Mondo dello Specchio, l’unica competente“5.
Ma quali sono gli elementi vittoriani? Innanzitutto l’infanzia e l’educazione vittoriana.
Un aspetto sicuramente centrale dell’opera è la riflessione sull’infanzia e sull’educazione vittoriana. L’infanzia era “universalmente considerata come una semplice fase nello sviluppo verso l’età adulta, da attraversare il più rapidamente possibile“6. Questa visione riduttiva negava al bambino un valore autonomo, trasformandolo in un soggetto da disciplinare rigidamente per prepararlo alla vita adulta. Tale mentalità si rifletteva anche nelle pratiche di accudimento.
“L’usanza di assumere una balia era ancora assai diffusa tra le classi più elevate, ed era attribuita alla leggerezza delle madri che, per dirla con le parole di Rousseau, anteponevano i “piaceri di società” alle esigenze dei figli. Ciò veniva condannato, insieme al timore di sciupare la propria linea e all’impossibilità di allattare causata dall’osservanza di una moda che imponeva “busti dannosi e giacchette rigide”. Questi fatti determinarono la massima diffusione della balia durante la seconda metà del XVIII secolo”7.
Di questo abbiamo testimonianza anche dalla Regina Vittoria, la quale ricevette una significativa influenza dalla propria domestica, la baronessa tedesca Louise von Lehzen.
“Dalla Lehzen la sovrana apprese i rudimenti delle conoscenze storiche e i principi morali; grazie a lei coltivò il gusto “artistico” nei campi più disparati: dalla confezione di vestiti per le sue numerose bambole alla realizzazione di disegni e pastelli. Le lezioni di professionisti le consentirono di perfezionare la tecnica grafica e di raggiungere livelli più che dignitosi”8.
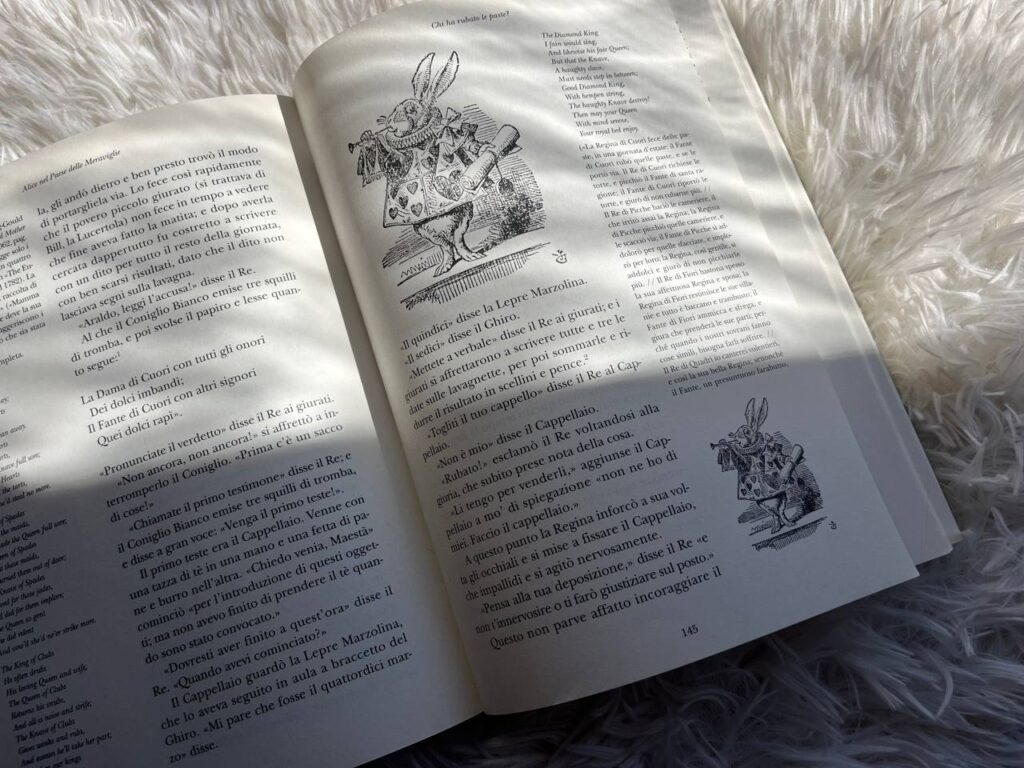
Anche nella famiglia di Alice compaiono figure domestiche tipiche del mondo vittoriano, come i lacchè – rappresentati simbolicamente dal Pesce-lacchè e dalla Rana-lacchè – figure essenziali nelle case nobiliari, che spesso fungevano da corrieri o attendenti. Allo stesso tempo, la scarsa presenza affettiva dei genitori portava molti bambini a legarsi agli animali domestici. Lo stesso avviene con Alice, affezionata alla sua micina Dina, che menziona spesso con affetto, e attratta dal Gatto del Cheshire, simbolo enigmatico e affascinante dell’opera.
“I lacchè erano indispensabili alle famiglie di rango, e la capacità di correre costituiva un requisito essenziale per un mestiere tra i cui compiti c’era quello di precedere a piedi la carrozza. Sebbene questo servizio non fosse più richiesto, l’opera dei lacchè era pur sempre indispensabile; essi infatti assolvevano l’importante funzione di corrieri. In una società in cui le esigenze dell’etichetta comportavano un intenso scambio di corrispondenza, era essenziale avere al proprio servizio un corriere svelto ed affidabile, a cui si richiedeva non solo di essere veloce, ma anche pratico dei dintorni o della città”9.
Per la presenza poco costante dei genitori, spesso impegnati nei loro affari, i bambini cercavano l’affetto mancante anche in figure come gli animali domestici. La stessa Regina Vittoria, come anticipato all’inizio del capitolo, viveva in simbiosi con il suo adorato Dash per il quale decise di scrivere una dedica sulla lapide,quando questi morì il 20 dicembre 1840 .

Allo stesso modo Alice, sia nel Paese delle Meraviglie sia in Al di là dello Specchio, fa spesso riferimento o è in compagnia delle sue care micine.
“– E chi è Dina, se posso chiederlo? – disse il Lorichetto. Alice rispose con entusiasmo, perché era sempre disposta a parlare della sua cocca”10.
All’inizio del romanzo troviamo Alice parlare apertamente della sua micina e delle sue abitudini di correre dietro a topi e ad uccelli, davanti al Topo – dopo la nuotata nel mare di lacrime – e davanti agli Uccelli protagonisti della Maratonda. Inoltre, un personaggio dal quale Alice fu fin da subito molto attratta è proprio il Gatto del Cheshire del quale, inevitabilmente, le rimane impresso il sorriso. Gli animali domestici non mancavano nelle famiglie vittoriane e rientravano tra i “passatempi preferiti” dai bambini solitari di quell’epoca.
Altro elemento cardine è l’istruzione. I bambini delle classi elevate ricevevano un’educazione privata, protetta da influenze esterne, con una forte impronta religiosa e morale,
“al riparo da influenze indesiderabili, quali il contatto con persone di condizione sociale inferiore o appartenenti all’altro sesso”11.
Le bambine dovevano coltivare grazia, religiosità e decoro, mentre ai maschi si richiedeva rigore, coraggio e cultura.
“Mentre le ragazze cercavano di acquisire il grado di religiosità più adeguato e la più raffinata eleganza, i ragazzi miravano all’apprendimento di “conoscenze in campo morale e politico, cose di cui si conviene che un gentleman si interessi. Loro sostegno nella vita avrebbero dovuto essere l’esercizio della devozione e del coraggio, il rispetto dei principi morali e l’aspirazione ad apprendere, tutte qualità simili a quelle indicate da Locke, ossia la virtù, la sapienza, la buona educazione e la cultura, le quattro doti di un gentleman.”12.
Questi aspetti dell’educazione emergono, attraverso richiami significativi, tra le righe di Alice nel Paese delle Meraviglie. Qui, Carroll sottolinea l’inefficienza di un’istruzione di questo tipo:
“l’autore riprendeva, azzerandoli, sia il mito dell’infanzia quale immagine di una innocenza originaria […], sia la fiducia nell’educazione di tipo utilitaristico che i vittoriani consideravano un viatico indispensabile per i loro ragazzi. “And what is the use of a book – pensa Alice dopo aver sbirciato quello che la sorella sta leggendo, “without pictures or conversation in it?”13
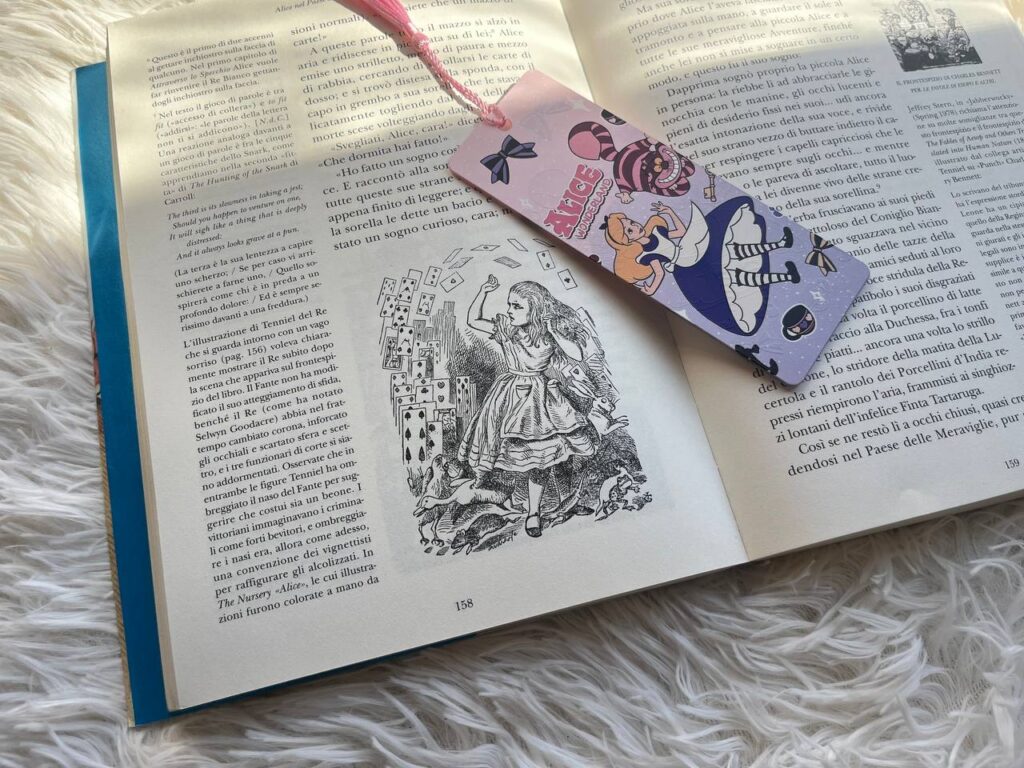
Significativi risultano essere gli episodi narrati dove Alice intrattiene un monologo in cui riporta alcune parole inerenti alla geografia delle quali però non conosce il significato. Ciò accade anche con le numerose filastrocche e poesie imparate a memoria che la stessa Alice si trova costretta a dover ripetere di tanto in tanto:
“La storpiatura dei nomi delle materie scolastiche è certo denuncia del sistema educativo che rende ostico e sgradevole ciò che insegna (Derisione per divisione, Bruttificazione per Moltiplicazione), ma non vi manca un grande senso di rimpianto per il dolce periodo dell’infanzia, due istanze diverse e contraddittorie, ma che coesistono all’interno di ciascun gioco di parole e che si concretizzano compiutamente nella trasformazione delle materie Latino e Greco (Laughing and Grief = risolino e dolor greggio), emblemi delle due istanze di gioia e di dolore dell’infanzia”14.
L’universo di Alice è, in definitiva, un luogo sospeso dove coesistono spensieratezza e disincanto, gioco e riflessione, ribellione e conformismo. È una metafora perfetta dell’ambivalenza vittoriana nei confronti dell’infanzia e della crescita. Dietro il nonsense e i personaggi bizzarri, Carroll nasconde una critica pungente alla società del suo tempo, riflettendo sul peso dell’educazione, sulla rigidità della morale e sull’assurdo che tutto questo può generare.
Con grande ironia e delicatezza, Carroll dà voce a una generazione silenziosa, educata all’obbedienza ma affamata di libertà. Nel suo viaggio attraverso mondi impossibili, Alice impara a mettere in discussione ciò che le è stato insegnato, a guardare la realtà con occhi nuovi e a portare con sé il lettore in questo percorso di scoperta. Proprio in questa continua tensione tra ordine e caos, educazione e immaginazione, l’opera di Carroll rimane sorprendentemente attuale, continuando a parlare alle generazioni future con la stessa forza e meraviglia di allora.
BIBLIOGRAFIA
W. H. AUDEN, Il “Mondo delle Meraviglie” attuale ha bisogno di Alice, 1962, in L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello specchio, traduzione di Alessandro Ceni, Giulio Einaudi editore, Torino, 2003 e 2005.
L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, London, The Nonesuch Press, 1977, p.15., cit. in A.R. SCRITTORI, “Alice” di Lewis Carroll: una fiaba vittoriana, in “Annali di Ca’ Foscari: Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Venezia”, 30, I – “, 1991.
L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello Specchio, traduzione di Alessandro Ceni, Giulio Einaudi editore, Torino, 2003 e 2015.
M. GRAFFI, Introduzione, in L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo specchio, traduzione di Milli Graffi, Garzanti, Milano, 2010.
J. LOCKE, Some Thoughts concerning Education, University Press, Cambridge 1880, p.155, 134. Pubblicato per la prima volta nel 1693, cit. in S. LASDUN, Vita di infanzia nell’età vittoriana. Il mondo dei bambini Drummond 1827 – 1832, traduzione di E. Mendes, Passigli Editori, Firenze, 1986.
R. MARX. La regina Vittoria e il suo tempo, Mulino, Bologna, 2000.
R. MUSCARDIN, Fantastico e narrazione in “Alice’s Adventures in Wonderland” e “Through the Looking – Glass” di Lewis Carroll, in “Annali di Ca’ Foscari: Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Venezia”, 30, 1-2, 1991.
S. LASDUN, Vita di infanzia nell’età vittoriana. Il mondo dei bambini Drummond 1827 – 1832, traduzione di E. Mendes, Passigli Editori, Firenze, 1986.
NOTE
1 R. MARX. La regina Vittoria e il suo tempo, Mulino, Bologna, 2000, p.13.
2 Ivi, p. 104.
3 Ivi, p. 68.
4 R. MUSCARDIN, Fantastico e narrazione in “Alice’s Adventures in Wonderland” e “Through the Looking – Glass” di Lewis Carroll, in “Annali di Ca’ Foscari: Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Venezia”, 30, 1-2, 1991, p.208.
5 W. H. AUDEN, Il “Mondo delle Meraviglie” attuale ha bisogno di Alice, 1962, in L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello specchio, traduzione di Alessandro Ceni, Giulio Einaudi editore, Torino, 2003 e 2005, p. XII.
6 S. LASDUN, Vita di infanzia nell’età vittoriana. Il mondo dei bambini Drummond 1827 – 1832, traduzione di E. Mendes, Passigli Editori, Firenze, 1986, p.11.
7 Ivi, p.25.
8 Ivi, p.14.
9 Ivi, p.81.
10 L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello Specchio, traduzione di Alessandro Ceni, Giulio Einaudi editore, Torino, 2003 e 2015, p. 27.
11 S. LASDUN, Vita di infanzia nell’età vittoriana. Il mondo dei bambini Drummond 1827 – 1832, traduzione di E. Mendes, Passigli Editori, Firenze, 1986, p. 45.
12 J. LOCKE, Some Thoughts concerning Education, University Press, Cambridge 1880, p.155, 134. Pubblicato per la prima volta nel 1693, cit. in S. LASDUN, Vita di infanzia nell’età vittoriana. Il mondo dei bambini Drummond 1827 – 1832, traduzione di E. Mendes, Passigli Editori, Firenze, 1986, p. 35.
13 L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, London, The Nonesuch Press, 1977, p.15., cit. in A.R. SCRITTORI, “Alice” di Lewis Carroll: una fiaba vittoriana, in “Annali di Ca’ Foscari: Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Venezia”, 30, I – “, 1991, p.290.
14 M. GRAFFI, Introduzione, in L. CARROLL, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo specchio, traduzione di Milli Graffi, Garzanti, Milano, 2010, p.XXII.



