In un saggio del 1966 dal titolo L’utopie littéraire, contenuto nel primo volume di Figures, Genette scriveva: «La littérature est bien ce champ plastique, cet espace courbe où les rapports les plus inattendus et les rencontres les plus paradoxales sont à chaque instant possibles». Aprire il mio intervento in questo modo potrebbe sembrare una scelta azzardata, forse anche incongruente, eppure credo che queste poche righe, scritte dall’autore pensando all’opera di Borges, riassumano in maniera eccellente il senso di queste mie bizzarre divagazioni.
Dante ha oltrepassato i confini dello spazio e del tempo, disseminando ovunque tracce evidenti della sua presenza e contribuendo alla costituzione di un immaginario collettivo che prescinde, anzi: che può far benissimo a meno ormai della conoscenza diretta dell’originale. Un “codice”, come lo definisce Daniele Pegorari (Cfr. Codice Dante. Cruces della ‘Commedia’ e intertestualità novecentesche, Stilo Editrice, Bari 2012), alludendo al tempo stesso alla potenza evocatrice della sua scrittura e al riconoscimento quasi genetico di un linguaggio comune per dire la postmodernità che da quella scrittura e da quell’immaginario, progressivamente cristallizzatosi, trae origine. Un codice che non si limita alla conquista del solo spazio letterario, ma poco a poco allarga il suo raggio di influenza ai più svariati ambiti della cultura contemporanea, dagli abissi del pop – penso alla pubblicità di una nota marca di carta da cucina – fino alle iperuraniche sfere celesti dell’Accademia.
Lo spazio curvo di cui parla Genette è il luogo, metaforico e fluido, in cui questi fantasmi, ricorrenti e fuggevoli, si ritrovano per creare contaminazioni, dissonanze, interferenze. È lo spazio dell’allusione criptica, della citazione velata, del riferimento anacronistico e dell’accostamento paradossale, terreno fecondo per sperimentazioni potenziali ed inattesi esercizi di stile. Ed è in questo luogo indefinito e vago, nel quale può accadere qualsiasi cosa, che intendo muovermi alla ricerca di tracce rivelatrici, orme talvolta leggere e impalpabili, talaltra profonde come solchi d’aratro.
Obiettivo di queste divagazioni è illustrare alcuni esempi, noti e del tutto ignoti, di pseudografie dantesche contemporanee. Siamo in un territorio ibrido, sospeso tra la dimensione del plagio e la riscrittura, l’interpolazione e la parodia, il gioco di specchi e la falsificazione. Ma sarà il caso di circoscrivere, con maggiore precisione, i confini di questo intervento, onde evitare pericolose derive senza possibilità di ritorno.
“Sia dato un segmento AB di misura pari al cammino della nostra vita e si consideri il punto medio M di tale segmento. Detto D un uomo di nome Dante, sia D coincidente con M. Sia inoltre il segmento AB tutto contenuto in una selva oscura So in modo che per ogni X appartenente ad AB, X appartiene ad So. Supponendo che esista una circonferenza C circoscritta alla selva So verificare che la retta via R sia esterna a tale circonferenza.”
Un vago senso di smarrimento mi pervade, sfogliando le pagine di Faximile, 49 riscritture di opere letterarie, antologia bizzarra e ricchissima di spunti creativi realizzata da Homo Scrivens, la prima compagnia italiana di scrittura, un laboratorio letterario coordinato da Aldo Putignano, che mira a promuovere l’operato di scrittori esordienti dediti al divertissement compulsivo. In poche righe la sintesi, lineare e geometrica, di una intera cantica infernale, di un complesso sistema filosofico e teologico, lungi da elucubrazioni critiche e da esercizi ginnici di interpretazione. Una riduzione ai minimi termini, indubbiamente, che tuttavia diviene indizio curioso, boccone saporito che invita il lettore a perdersi nell’oscura luminosità dei versi danteschi qui liofilizzati e resi commestibili per un pubblico dal palato non più avvezzo ad assaporarli integralmente. L’autore sceglie di utilizzare il linguaggio asettico della geometria, una scrittura limpida e non soggetta ad interpretazioni fallaci, che riduce a problema risolvibile, nonché agilmente dimostrabile, una struttura estremamente complessa come quella della Commedia. Ci si potrebbe interrogare sulla paternità di queste righe apocrife, specie in un’epoca come la nostra, così densa di azioni volontarie e tuttavia compiute a propria insaputa. Il fatto che siano apparse all’improvviso, secoli dopo, presso i tipi di Fratelli Frilli Editori, nulla toglie all’autenticità dell’esperimento, nulla alla potenza evocatrice del codice, di fronte alla quale viene meno la necessità stessa di una reale presenza creatrice. Un esercizio di letteratura inesistente, àmbito privilegiato di ricerca del collettivo di scrittori citati in precedenza (ideatori, ad esempio, di una Enciclopedia degli Scrittori Inesistenti 2.0, pubblicata qualche anno fa a conclusione del progetto sperimentale “Polimeri”). Autori inesistenti di opere altrettanto inesistenti, gioco letterario e intellettuale che richiama I mattoidi italiani di Paolo Albani (Quodlibet, Macerata 2012) e le sue recensioni immaginarie raccolte ne Il sosia laterale, ispiratrici di una recente plaquette dell’Oplepo, intitolata Eclisse: recensioni preventive, il cui procedimento è illustrato da Umberto Eco nella «Bustina di Minerva» del 26 febbraio 2015. Incroci non casuali, come vedremo tra poco. Abbiamo tuttavia un indizio su cui concentrare l’attenzione. In questo tipo di produzione letteraria la scrittura occupa uno spazio assoluto e illimitato, pervadendo ogni millimetro disponibile e oscurando la figura del creatore, ridotto a mero “mezzo scrivente”. È superfluo interrogarsi sulla sua identità, poiché ciò che interessa realmente è svelare il meccanismo che produce il testo, la regola ferrea che è alla base e che, idealmente, diviene unica forza generatrice.
 Nel 2006, per le edizioni Nottetempo, Umberto Eco pubblica un libello grazioso e leggero intitolato Sator Arepo eccetera, nel quale sono contenuti per stessa ammissione dell’autore giochi linguistici nati in forma privata come scambio tra amici e contendenti (ad esempio l’enigmista Stefano Bartezzaghi, anch’egli già da tempo membro dell’Oplepo); si tratta dell’ideale seguito del Secondo diario minimo, pubblicato nel 1992, ma più incentrato sui principi dell’Oulipo rispetto alla piccola sezione conclusiva intitolata Giochi di parole dalla quale tuttavia si intuisce chiaramente il profondo interesse nutrito dall’autore, nel corso della sua vita letteraria e scientifica, per certi meccanismi creativi. In questo piccolo volume ci si imbatte in lipogrammi, omofoni, omografi e in una complessa variazione sul Sator Arepo, il noto enigma medievale, altrimenti detto quadrato magico, ma anche in due esercizi danteschi su cui vorrei soffermarmi.
Nel 2006, per le edizioni Nottetempo, Umberto Eco pubblica un libello grazioso e leggero intitolato Sator Arepo eccetera, nel quale sono contenuti per stessa ammissione dell’autore giochi linguistici nati in forma privata come scambio tra amici e contendenti (ad esempio l’enigmista Stefano Bartezzaghi, anch’egli già da tempo membro dell’Oplepo); si tratta dell’ideale seguito del Secondo diario minimo, pubblicato nel 1992, ma più incentrato sui principi dell’Oulipo rispetto alla piccola sezione conclusiva intitolata Giochi di parole dalla quale tuttavia si intuisce chiaramente il profondo interesse nutrito dall’autore, nel corso della sua vita letteraria e scientifica, per certi meccanismi creativi. In questo piccolo volume ci si imbatte in lipogrammi, omofoni, omografi e in una complessa variazione sul Sator Arepo, il noto enigma medievale, altrimenti detto quadrato magico, ma anche in due esercizi danteschi su cui vorrei soffermarmi.

Il titolo è À rebours, ma l’intento non è certo quello di evocare le atmosfere decadenti e morbose di Huysmans, pur creando con questa allusione un ulteriore richiamo, un più profondo sottotesto, ludico e cervellotico insieme. Si tratta tecnicamente di un “Dante all’indietro” o per meglio dire ‘al contrario’, che ha illustri precedenti con i quali il nostro autore vuole confrontarsi scegliendo il campo di battaglia degli “irresponsabili divertimenti”, del gioco gratuito e sfrenato con una lingua che appare sempre più materica e plasmabile, concreta e multiforme. L’idea viene da un libretto di Giampaolo Dossena (T’odio empia vacca, dileggio e descolarizzazione, Rizzoli 1994) in cui sono raccolte 14 poesie ben note a tutti gli italiani per “costrizione scolastica”. Di queste poesie è poi proposta con testo a fronte una versione al contrario. Succede così che ‘La nebbia agli irti colli piovigginando sale’ (Carducci) diventi ‘L’eccellente visibilità alle ravviate pianure perdurando il clima secco, cala’. Il celebre ‘Albero a cui tendevi la pargoletta mano’ (Carducci) sarà ‘L’erba onde ritraevi il tuo grosso piedone’. Il dannunziano ‘Settembre andiamo. È tempo di migrare’ divenga invece ‘Marzo venite. C’è spazio per restare’. E poi ancora Leopardi con ‘Sempre caro mi fu quest’ermo colle’ / ‘Mai odioso sarà quell’imo piano’ e sempre Leopardi con ‘La donzelletta vien dalla campagna’ / ‘La modellista è in metropolitana’. E così via. Mai nessuno si era spinto tuttavia a piegare il testo dantesco alle regole di questo gioco di specchi dall’esito divertente e, al tempo stesso straniante.
“Inferno – Canto I
Nel mezzo del cammin di nostra
vita Mi ritrovai per una selva
oscura,
ché la diritta via era smarrita
Ahi quanto a dir qual era è cosa
dura Esta selva selvaggia e aspra e
forte Che nel pensier rinova la paura!
Al margin del ristar di vostra
morte mi persi in un deserto
illuminato, ritrovando le piazze
più distorte.
Hip hip come a tacer son consolato
di questa piana mite e assai civile
Di cui parlar mi fa rassicurato!
Inferno – Canto V
Quando leggemmo il disiato riso
Esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me fu diviso,
la bocca mi basciò tutto
tremante. Galeotto ’l libro e chi
lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante
E non sapendo quale ghigno
atroce dia l’esser morso dal marito
odiato, costei, che fugge verso
un’altra foce,
gelidamente il naso m’ha azzannato.
Amnistiato fu il libro ed a chi
piacque: dopo l’abbiamo a lungo
consultato.”
Al capovolgimento giocoso dei passi citati, si aggiunge una trasposizione oscena e greve del canto XXXIII dell’Inferno, che ci restituisce un conte Ugolino in preda alla furia sessuale conseguente a ben altro genere di digiuno. È un testo poco consono alle circostanze, malgrado ormai le nostre orecchie siano avvezze a sconcezze decisamente più disturbanti di qualche verso osé. Ciò che colpisce in questi testi è la capacità mimetica di entrare in un meccanismo ed adattarvisi, stravolgendo sì il senso del testo originario senza tuttavia inficiarne l’atmosfera, lo stile, l’essenza. Sembra quasi che si respirino atmosfere infernali in questi esperimenti, all’appello non manca nessun elemento genuinamente dantesco (rime, assonanze, metrica, terzina) e l’espediente del testo a fronte rende ancor più evidente la struttura di questa contrainte: non si tratta di un puro capovolgimento parodico – troppo semplice, in fondo, entrare in un classico della letteratura come un cavallo di Troia e farlo esplodere dall’interno – ma di creare un testo rovesciato che mantenga saldo il legame con il modello, al punto da sembrare, a sua volta, ulteriore modello di cui l’originale divenga il rovescio. Maneggiare materiale dantesco e plasmarlo per dargli nuova vita, nuova forma, nuovo senso: non semplice riscrittura rispettosa di stilemi e atmosfere, ma restituzione di un’essenza riconoscibile, attraverso la potenza evocatrice di una lingua che ha profondamente mutato il nostro sentimento della realtà. È tale la capacità mimetica del linguaggio poetico che non ci sembrerà assurdo leggere un inedito componimento poetico di Dante su Saussure, contenuto nel Secondo diario minimo. Un gioco, certo, che investe tuttavia innumerevoli ambiti di conoscenza, un gioco illuminato dall’ironia, reso sapido da una profonda erudizione e offerto al pubblico con il sorriso compiaciuto di chi sa che non c’è nulla di più serio di uno scherzo meravigliosamente ordito.
“Colà dove il Lemanno forma vuoti
A cui l’Alpe nevosa un pieno
oppone, tracciando paragrammi
ancora ignoti
Ferdinando il sistema suo dispone:
e come su scacchiera ove ogni
pezzo non per la sua presenza si
propone
ma dalla differenza trae il suo
prezzo, l’un contro l’altro sol
staglia valori
per amor di struttura e non per vezzo,
che come il bianco al nero e il dentro al
fuori disegnano quel senso cui l’assenza
per un imprescindibile a priori,
non si genera mai dalla
presenza ma soltano dall’alta
strategia
dovuta al predominio di una Assenza.
Ahi, quale dura e asperrima la via
disegnasti, o Saussure, ai tuoi seguaci
di quella strutturale sincronia
che d’ogni foglio sparso fece
faci a illuminare anco a Praga la
strada che poi seguendo i Danesi
capaci
verso Parigi un giorno alfin degrada.”
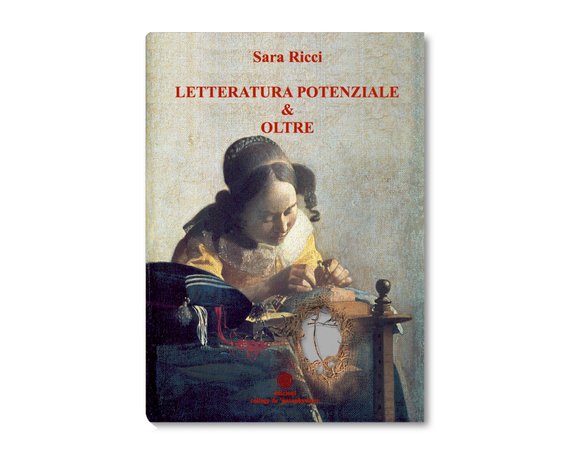 Si comincia ad intuire quali siano i cardini del discorso potenziale: la parola come oggetto ludico, utilizzata in tutte le sue possibili sfaccettature, non solo semantiche ma anche strutturali: le permutazioni consonantiche e vocaliche, la metatesi sillabica, gli spostamenti di accento, gli equivoci generati da parole omofone. E lo spazio dell’inesistente, che consente all’idea letteraria di esprimersi nella massima libertà, attraverso la lente deformante dell’ironia. Non si tratta di una corrente sotterranea del fantastico, di una elitaria nicchia di stregoni del linguaggio che si diletta nella chirurgia della singola sillaba. Giochi di parole, indovinelli, rebus. Sembra che si sconfini nell’enigmistica pura. In parte è vero, ma non sarei propensa a ridurre il tutto in questi termini. Attraverso questi mezzi ‘tecnici’ si cerca di approdare a un testo letteraio, con esiti non sempre convincenti ma in ogni caso mai privi di interesse. Eco è autore legato al Collège di Pataphysique e all’Oulipo, sua sottocommissione di lavoro letterario; nel 1990 a Capri nasce ufficialmente l’Oplepo, opificio di letteratura potenziale, costola italiana del gruppo francese, per volontà di Raffaele Aragona, Ruggero Campagnoli e Domenico D’Oria, che attualmente ricopre la carica di Presidente dopo l’occultazione di Edoardo Sanguineti. Negli anni di sperimentazione hanno visto la luce una trentina di plaquettes a tiratura limitata che raccolgono esercizi, contraintes, testi multiformi, poesia visiva, commistioni musicali e pittoriche. E non poteva mancare un omaggio a Dante, in questo gioco di interferenze, allusioni e citazioni. Incentrata sul dialogo possibile tra i nostri maggiori patres, Dante e Petrarca, la plaquette di Piero Falchetta si intitola Frammenti in vita. Combinazioni monorime con commento. La tecnica è semplice: si tratta di estrarre dalla Commedia e dal Canzoniere una scelta di rime terminanti in –ita (scelta che l’autore definisce ‘patriottica’), cercando di combinarle insieme, e alternando, se possibile, i versi dell’uno e dell’altro poeta. L’esito è alquanto curioso. Presi singolarmente, i frammenti non perdono nulla della loro potenza espressiva; combinati insieme creano un effetto umoristico, rafforzato dalla chiosa, o commento, talvolta costruito con materiale poetico contemporaneo, talaltra semplicemente inventato dall’autore attingendo al quotidiano, al pastiche, alla farsa, all’annuncio su giornale, alla citazione inventata. Il procedimento combinatorio, ancora una volta, è affidato all’arbitrio dell’autore, il quale, tuttavia, utilizza materiale che non può essere modificato, ma solo manipolato e ricucito insieme. La scelta di attingere a un patrimonio poetico così prezioso amplifica la portata del gioco, estendendola a livelli più profondi (erudizione, citazione, imitazione). Si sconfina nel territorio della parodia, utilizzando una tecnica che ha una lunga tradizione letteraria: il centone. Petronio ha utilizzato versi celebri dell’Eneide virgiliana per dar voce al monologo, o al dialogo impossibile di Encolpio con il suo membro virile, sordo a qualsiasi sollecitazione, facendo precipitare l’epos dalle vette olimpiche al proprio basso ventre e generando nel lettore un effetto comico amplificato dallo stravolgimento della nobile materia adoperata. L’intento di Falchetta è più moderato, più incline al puro divertissement, e l’esito è indubbiamente felice. Eccone alcuni esempi:
Si comincia ad intuire quali siano i cardini del discorso potenziale: la parola come oggetto ludico, utilizzata in tutte le sue possibili sfaccettature, non solo semantiche ma anche strutturali: le permutazioni consonantiche e vocaliche, la metatesi sillabica, gli spostamenti di accento, gli equivoci generati da parole omofone. E lo spazio dell’inesistente, che consente all’idea letteraria di esprimersi nella massima libertà, attraverso la lente deformante dell’ironia. Non si tratta di una corrente sotterranea del fantastico, di una elitaria nicchia di stregoni del linguaggio che si diletta nella chirurgia della singola sillaba. Giochi di parole, indovinelli, rebus. Sembra che si sconfini nell’enigmistica pura. In parte è vero, ma non sarei propensa a ridurre il tutto in questi termini. Attraverso questi mezzi ‘tecnici’ si cerca di approdare a un testo letteraio, con esiti non sempre convincenti ma in ogni caso mai privi di interesse. Eco è autore legato al Collège di Pataphysique e all’Oulipo, sua sottocommissione di lavoro letterario; nel 1990 a Capri nasce ufficialmente l’Oplepo, opificio di letteratura potenziale, costola italiana del gruppo francese, per volontà di Raffaele Aragona, Ruggero Campagnoli e Domenico D’Oria, che attualmente ricopre la carica di Presidente dopo l’occultazione di Edoardo Sanguineti. Negli anni di sperimentazione hanno visto la luce una trentina di plaquettes a tiratura limitata che raccolgono esercizi, contraintes, testi multiformi, poesia visiva, commistioni musicali e pittoriche. E non poteva mancare un omaggio a Dante, in questo gioco di interferenze, allusioni e citazioni. Incentrata sul dialogo possibile tra i nostri maggiori patres, Dante e Petrarca, la plaquette di Piero Falchetta si intitola Frammenti in vita. Combinazioni monorime con commento. La tecnica è semplice: si tratta di estrarre dalla Commedia e dal Canzoniere una scelta di rime terminanti in –ita (scelta che l’autore definisce ‘patriottica’), cercando di combinarle insieme, e alternando, se possibile, i versi dell’uno e dell’altro poeta. L’esito è alquanto curioso. Presi singolarmente, i frammenti non perdono nulla della loro potenza espressiva; combinati insieme creano un effetto umoristico, rafforzato dalla chiosa, o commento, talvolta costruito con materiale poetico contemporaneo, talaltra semplicemente inventato dall’autore attingendo al quotidiano, al pastiche, alla farsa, all’annuncio su giornale, alla citazione inventata. Il procedimento combinatorio, ancora una volta, è affidato all’arbitrio dell’autore, il quale, tuttavia, utilizza materiale che non può essere modificato, ma solo manipolato e ricucito insieme. La scelta di attingere a un patrimonio poetico così prezioso amplifica la portata del gioco, estendendola a livelli più profondi (erudizione, citazione, imitazione). Si sconfina nel territorio della parodia, utilizzando una tecnica che ha una lunga tradizione letteraria: il centone. Petronio ha utilizzato versi celebri dell’Eneide virgiliana per dar voce al monologo, o al dialogo impossibile di Encolpio con il suo membro virile, sordo a qualsiasi sollecitazione, facendo precipitare l’epos dalle vette olimpiche al proprio basso ventre e generando nel lettore un effetto comico amplificato dallo stravolgimento della nobile materia adoperata. L’intento di Falchetta è più moderato, più incline al puro divertissement, e l’esito è indubbiamente felice. Eccone alcuni esempi:
“I
Nel mezzo del cammin di nostra
vita L’ultimo dì, ch’è primo a
l’altra vita.
Monsieur de Lapalisse
C’è un giorno, a metà della nostra vita,
che è l’ultimo della prima metà e il primo della seconda
metà (purché il totale sia un numero dispari).
V
Son fuggito io per allungar la vita
Sempre pensando; e questo sol
m’aita. La mia favola breve è già
compita.
Parafrasi del poeta
Ognuno sta solo sul cuor della
terra Trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.”
Nel primo caso, la chiosa è estremamente didascalica: il distico viene commentato nello stile degli scholia tardoantichi, con l’inserimento di notizie superflue, concentrate su particolari insignificanti, che nulla aggiungono alla comprensione del testo. A dar voce a questa tautologia, Falchetta sceglie proprio Monsieur de Lapalisse, incarnazione di ovvietà e inutili precisazioni. Il secondo caso richiede l’intervento di un terzo poeta, che si sovrappone ai due: si crea quindi un centone composito in cui anche il commento, o parafrasi poetica, è generato da materiale preesistente; l’effetto ludico è assicurato dall’utilizzo di versi riconoscibili, riconducibili al vero autore e dallo stridente accostamento tra due linguaggi poetici abissalmente differenti, legati tuttavia da un sottile filo di significato. Ma si tratta di un esercizio di cui sono evidenti i limiti, che svaniscono invece nella testimonianza più straordinaria di pseudografia dantesca nella quale mi sia mai imbattuta in questi anni di ricerca.
 La diciottesima plaquette della Biblioteca Oplepiana realizza il sogno vagheggiato dai filologi di ogni tempo: scoprire, in un testo consacrato alla tradizione, un potenziale indizio di novità, che rimetta in discussione secoli di esegesi e diatribe letterarie. È quello che accade a Luca Chiti ne Il centunesimo canto. Philologica dantesca, gioiello di combinatoria, costruito sapientissimamente al punto da sembrare, anzi essere, vero. L’autore, un anonimo appassionato di filologia che potrebbe coincidere con lo stesso Chiti, narra, in una cornice funzionale alla verosimiglianza, della occasionale scoperta di Giovanni Ciancaglini, timido studente del Liceo classico Machiavelli, il quale scorge, in un’edizione scolastica della Commedia dantesca, una macchia insolita collocata tra il canto XXIX e il XXX dell’Inferno. Ossessionato da quell’ombra brumosa della carta, non attribuibile alle comuni macchie di inchiostro che funestano le edizioni moderne, procede a un’osservazione più accurata: appassionato di fotografia, utilizza il suo armamentario per procedere a una serie di ingrandimenti, fino alla sconvolgente scoperta. La macchia incriminata contiene in forma miniaturizzata un ulteriore canto, apparentemente dantesco, occultato per secoli da commentatori antichi e moderni. Resta da comprenderne la motivazione, ma Ciancaglini decide di seppellire il tutto nel silenzio. Una sera a cena, molti anni dopo, il fortuito incontro con l’autore del resoconto, appassionato di filologia, risveglia la sopita passione: il segreto viene rivelato e il filologo, scettico, decide di risolvere la questione in breve tempo, convinto della bonaria follia di Ciancaglini. Tuttavia, alle prese con la macchiolina e con i successivi ingrandimenti, viene coinvolto in un vortice di supposizioni, congetture e dubbi:
La diciottesima plaquette della Biblioteca Oplepiana realizza il sogno vagheggiato dai filologi di ogni tempo: scoprire, in un testo consacrato alla tradizione, un potenziale indizio di novità, che rimetta in discussione secoli di esegesi e diatribe letterarie. È quello che accade a Luca Chiti ne Il centunesimo canto. Philologica dantesca, gioiello di combinatoria, costruito sapientissimamente al punto da sembrare, anzi essere, vero. L’autore, un anonimo appassionato di filologia che potrebbe coincidere con lo stesso Chiti, narra, in una cornice funzionale alla verosimiglianza, della occasionale scoperta di Giovanni Ciancaglini, timido studente del Liceo classico Machiavelli, il quale scorge, in un’edizione scolastica della Commedia dantesca, una macchia insolita collocata tra il canto XXIX e il XXX dell’Inferno. Ossessionato da quell’ombra brumosa della carta, non attribuibile alle comuni macchie di inchiostro che funestano le edizioni moderne, procede a un’osservazione più accurata: appassionato di fotografia, utilizza il suo armamentario per procedere a una serie di ingrandimenti, fino alla sconvolgente scoperta. La macchia incriminata contiene in forma miniaturizzata un ulteriore canto, apparentemente dantesco, occultato per secoli da commentatori antichi e moderni. Resta da comprenderne la motivazione, ma Ciancaglini decide di seppellire il tutto nel silenzio. Una sera a cena, molti anni dopo, il fortuito incontro con l’autore del resoconto, appassionato di filologia, risveglia la sopita passione: il segreto viene rivelato e il filologo, scettico, decide di risolvere la questione in breve tempo, convinto della bonaria follia di Ciancaglini. Tuttavia, alle prese con la macchiolina e con i successivi ingrandimenti, viene coinvolto in un vortice di supposizioni, congetture e dubbi:
“C’era infatti il fondatissimo dubbio che si trattasse di un falso. Proprio questa, anzi, era l’ipotesi più probabile. È vero che la buona fede del Ciancaglini pareva fuori discussione, ma poteva essere stato, anni prima, vittima di una beffa. Geniale, però, e finissima, poiché presupponeva l’esistenza di una mente, non solo spiritosa, ma raffinatissima, capace di un tour de force letterario come quello dell’invenzione di sana pianta di un canto della Commedia secondo il tono e lo stile dell’autore (non avevo ancora realizzato, frastornato dai discorsi del mio ospite, la stupefacente circostanza che quei versi erano tutti di Dante) e in possesso di tecniche sopraffine di riduzione delle dimensioni del testo. Tutto questo rendeva l’ipotesi dello scherzo meno probabile. E, poi, a che scopo?”
 Il filologo vaglia tutte le edizioni in suo possesso della Commedia, alla ricerca della fatale imperfezione. Scopre così che si presenta in tutti i testi stampati fin dalle edizioni manoscritte del XIV secolo, il che gli impone, per risolvere il mistero, di procedere all’esegesi e al commento del nuovo testo appena ritrovato. Ecco che la mistery story filologica si trasforma in un accuratissimo e ineccepibile commento, degno delle migliori edizioni della Commedia, con in appendice la biografia del personaggio chiave dell’episodio nascosto, costruita imitando il modello dell’Enciclopedia dantesca. Restano da chiarire due misteri: la composizione del testo e la sua collocazione in quel determinato punto della cantica infernale. Si scopre che i versi sono tutti danteschi eccetto i vv. 23- 24, modificati per consentire l’inserimento del nome del personaggio misterioso (l’autore-filologo ne riporta l’esatta provenienza, varianti incluse). Tecnicamente sarebbe un centone, ma Chiti non può accontentarsi di una spiegazione tanto semplicistica e di applicare un procedimento, tutto sommato, così abusato e rozzo. Costruisce infatti, attorno alla composizione di questo canto e al successivo nascondimento da parte dell’autore, un’architettura di motivazioni verosimili: dallo sconvolgimento dell’ordine prestabilito (i 100 canti iniziali: 1+33+33+33 che rappresentavano, nel progetto iniziale, al tempo stesso unità e trinità attraverso la potenza cabalistica e dottrinale dei numeri) alle motivazioni personali, intrise di cupo pessimismo, livore e disincanto, che avrebbero creato una dissonanza con la ricercata armonia dell’opera. «Continuiamo a dare i numeri: 100+1=101. Numero primo. Discordanza, disomogeneità, molteplicità. Struttura atomizzata in 101 parti. E perché allora non 103, 107 o 117? Attrito, casualità, disordine. Immagine improponibile di un Dio di natura caotica, di volontà imprevedibile, di volpino potere. Inquietante incertezza di leggi fisiche e morali». Il contenuto del centunesimo canto è sconfortante, si narra di un dannato, l’insolente Gruccio de’ Bardonecchi, che rivendica la giustezza della sua condotta peccaminosa sulla terra e annuncia la sua assunzione in cielo, perfettamente in linea con la volontà divina. Dante cerca per ben due volte di controbattere, lanciandosi in una delle sue solite tirate, ma viene interrotto in modo brusco. Non gli resta che compiere un gesto impensabile: afferrare il dannato per la collottola e apostrofarlo con male parole. La rissa viene interrotta dalla voce di Dio che chiama a sé Gruccio, facendolo accomodare su un carro trionfale. Argomento scandaloso, indubbiamente, che avrebbe collocato Dante in odore di eresia. Per questa ragione, l’autore utilizza l’espediente dell’occultamento: la struttura perfetta dell’opera permane, con una infinitesimale macchia, collocata in un punto preciso, per fornire ai critici e i filologi antichi e moderni la chiave per risolvere il mistero. Il canto XXIX dell’Inferno si chiude con l’episodio di Capocchio, il falsario, famoso per le sue capacità miniaturizzanti. Si racconta che avesse dipinto sulle unghie delle mani una perfetta riproduzione della Passione di Cristo, cancellata con un colpo di lingua al sopraggiungere di Dante. Un indizio prezioso inserito in posizione decisamente strategica. Capocchio è un alchimista, un mago. E Luca Chiti utilizza i medesimi espedienti per compiere questa straordinaria impresa: dar vita a un gioco che è insieme combinatorio, filologico, storico-critico, insinuando il dubbio, sempre fecondo, che non si possa mai dare per scontati neppure i testi ‘sacri’ del nostro patrimonio letterario. Uno scherzo ordito con incredibile maestria, acutezza, ingegno: uno scherzo che segna il trionfo della fantasia e dell’inventiva sull’idea di percepire l’opera come qualcosa di definitivo, chiuso, immutabile.
Il filologo vaglia tutte le edizioni in suo possesso della Commedia, alla ricerca della fatale imperfezione. Scopre così che si presenta in tutti i testi stampati fin dalle edizioni manoscritte del XIV secolo, il che gli impone, per risolvere il mistero, di procedere all’esegesi e al commento del nuovo testo appena ritrovato. Ecco che la mistery story filologica si trasforma in un accuratissimo e ineccepibile commento, degno delle migliori edizioni della Commedia, con in appendice la biografia del personaggio chiave dell’episodio nascosto, costruita imitando il modello dell’Enciclopedia dantesca. Restano da chiarire due misteri: la composizione del testo e la sua collocazione in quel determinato punto della cantica infernale. Si scopre che i versi sono tutti danteschi eccetto i vv. 23- 24, modificati per consentire l’inserimento del nome del personaggio misterioso (l’autore-filologo ne riporta l’esatta provenienza, varianti incluse). Tecnicamente sarebbe un centone, ma Chiti non può accontentarsi di una spiegazione tanto semplicistica e di applicare un procedimento, tutto sommato, così abusato e rozzo. Costruisce infatti, attorno alla composizione di questo canto e al successivo nascondimento da parte dell’autore, un’architettura di motivazioni verosimili: dallo sconvolgimento dell’ordine prestabilito (i 100 canti iniziali: 1+33+33+33 che rappresentavano, nel progetto iniziale, al tempo stesso unità e trinità attraverso la potenza cabalistica e dottrinale dei numeri) alle motivazioni personali, intrise di cupo pessimismo, livore e disincanto, che avrebbero creato una dissonanza con la ricercata armonia dell’opera. «Continuiamo a dare i numeri: 100+1=101. Numero primo. Discordanza, disomogeneità, molteplicità. Struttura atomizzata in 101 parti. E perché allora non 103, 107 o 117? Attrito, casualità, disordine. Immagine improponibile di un Dio di natura caotica, di volontà imprevedibile, di volpino potere. Inquietante incertezza di leggi fisiche e morali». Il contenuto del centunesimo canto è sconfortante, si narra di un dannato, l’insolente Gruccio de’ Bardonecchi, che rivendica la giustezza della sua condotta peccaminosa sulla terra e annuncia la sua assunzione in cielo, perfettamente in linea con la volontà divina. Dante cerca per ben due volte di controbattere, lanciandosi in una delle sue solite tirate, ma viene interrotto in modo brusco. Non gli resta che compiere un gesto impensabile: afferrare il dannato per la collottola e apostrofarlo con male parole. La rissa viene interrotta dalla voce di Dio che chiama a sé Gruccio, facendolo accomodare su un carro trionfale. Argomento scandaloso, indubbiamente, che avrebbe collocato Dante in odore di eresia. Per questa ragione, l’autore utilizza l’espediente dell’occultamento: la struttura perfetta dell’opera permane, con una infinitesimale macchia, collocata in un punto preciso, per fornire ai critici e i filologi antichi e moderni la chiave per risolvere il mistero. Il canto XXIX dell’Inferno si chiude con l’episodio di Capocchio, il falsario, famoso per le sue capacità miniaturizzanti. Si racconta che avesse dipinto sulle unghie delle mani una perfetta riproduzione della Passione di Cristo, cancellata con un colpo di lingua al sopraggiungere di Dante. Un indizio prezioso inserito in posizione decisamente strategica. Capocchio è un alchimista, un mago. E Luca Chiti utilizza i medesimi espedienti per compiere questa straordinaria impresa: dar vita a un gioco che è insieme combinatorio, filologico, storico-critico, insinuando il dubbio, sempre fecondo, che non si possa mai dare per scontati neppure i testi ‘sacri’ del nostro patrimonio letterario. Uno scherzo ordito con incredibile maestria, acutezza, ingegno: uno scherzo che segna il trionfo della fantasia e dell’inventiva sull’idea di percepire l’opera come qualcosa di definitivo, chiuso, immutabile.
L’eco di Dante non svanisce, dissolvendosi nella rete del gioco letterario, ma diviene espediente poetico di forte impatto sociologico: capita così di leggere nell’ultima raccolta di Edoardo Sanguineti, uscita postuma ma in realtà già strutturata dall’autore prima di morire, Sette terzine cosmochaotiche, costruite rispettando lo schema della terzina dantesca, arricchito tuttavia dall’inserimento di assonanze, tautogrammi e sonorità ripetute ossessivamente, che lasciano emergere una furia polemica e al tempo stesso ludica, di sapore alquanto patafisico e potenziale, del poeta enigmista e creatore di parole nuove per dire il mondo. Parole che, tuttavia, traggono origine in quel magma infernale e pulsante che non ha mai smesso di sobbollire.
“1
dominanti divetti ducettini,
hysteroidi hypocristi homuncolini,
ipernazistici italoforzini!
2
puttana patria polipervertita
bubbonico bordello, berluschita
querula quadrantaria quartanita!
3
neonarcisi neocon neobushoneschi,
ruinosi rospacci ruineschi,
tremendi tremonteschi trepunteschi!
4
cosmico caos, che crudo cubo cupo,
mondialesco, mercato, macrolupo
grave, gravido globo, geodirupo!
5
ecco empi episcopalici egocentrici,
scemotti satanelli subeccentrici,
obnubilanti orcastri opacocentrici!
6
fracassata fottuta, forzitalico
Arcilupanaresco aidsescoidalico,
leghistico littorio lipolalico!
7
zoomorfi zeri zetamorfinosi,
villanrifatti, venovaricosi,
ultrà uhùh ultrultrultrultrultruosi!”
Certo questi non sono versi di Dante, ma dantesco è l’esprit che ci accompagna nel nostro quotidiano inferno, intervallato da pazienti attese e squarci ineffabili di luce. Non posso che concludere questa carrellata di bizzarrie con un piccolo tributo all’enigmistica, mia antica ossessione. “Se chi sta t’ode”, ovvero, anagrammando, “Et de hoc satis”.




