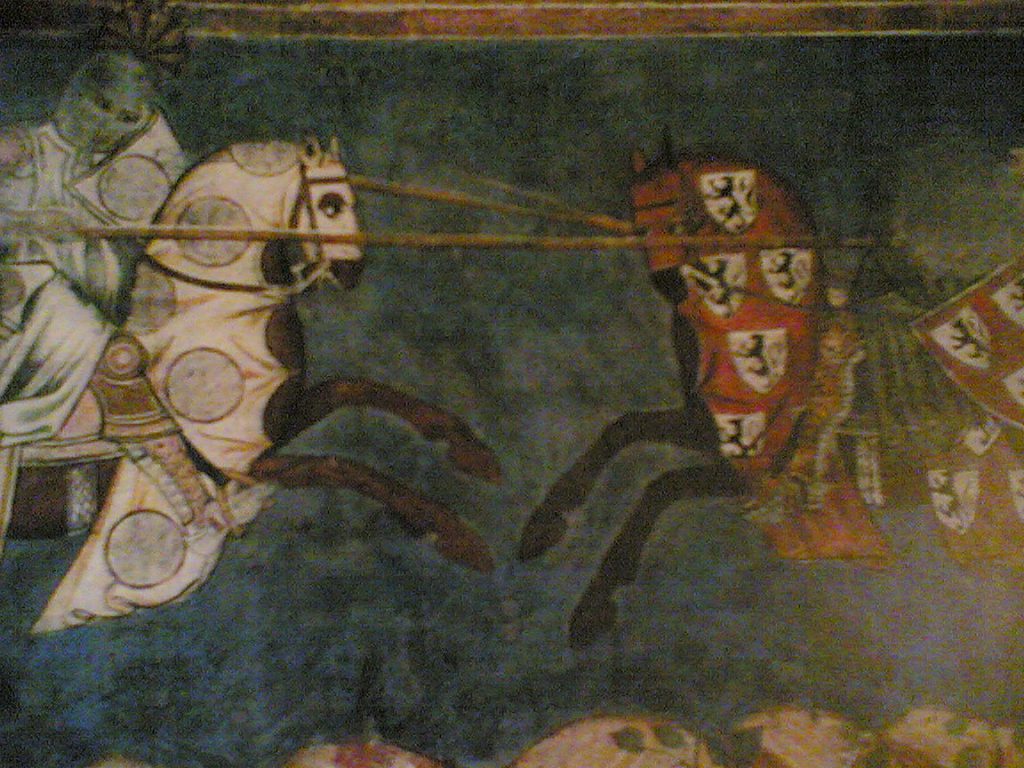Il poeta senese Cecco Angiolieri (1260-1312?) è noto per essere una voce fuori dal coro sotto molti aspetti, ma in realtà non è che la nave ammiraglia di una degna flotta avversaria (potremmo dire, meno teatralmente, concorrenziale) a quella che solcava liberamente i mari della fine del Duecento.

I suoi componimenti e le tematiche in essi trattate si iscrivono perfettamente nel solco di una nuova poetica che si stava affermando in Toscana in quegli anni, ovvero la poesia comica. Essa intendeva contrapporsi alla poesia siculo-toscana e stilnovistica, riprendendone linguaggio e topoi per rovesciarli parodisticamente, e l’apporto di Cecco Angiolieri alle produzioni di Rustico Filippi (1230/1240 – 1291/1300) e Folgòre di San Gimignano (1270 – 1332) fu essenziale alla canonizzazione di questo genere.
Non avendo notizie granché precise riguardo la sua biografia, il lettore che voglia cogliere qualcosa in più non può che affidarsi alla sua produzione letteraria.
La personalità che se ne ricostruirebbe indagando nel suo Canzoniere, fra i più ricchi e significativi del tempo (si parlava di 150 sonetti, via via ridotti a 120 circa, dopo gli studi condotti su di esso), è quella di un uomo irrequieto, scapestrato, dedito ai divertimenti – il gioco d’azzardo – e ai piaceri carnali – il sesso e la buona tavola (“Tre cose solamente m’ènno in grado / le quali posso non ben ben fornire / cioè la donna, la taverna e ’l dado”, Sonetti, 87), qualora non si mettano di mezzo la giustizia (in questo caso si hanno testimonianze documentarie) o gli affetti, come il padre, un uomo avaro che non lo sostiene economicamente nella sua vita dissoluta (“S’i’ fosse morte, andarei da mio padre / S’i’ fosse vita, fuggirei da lui”, Sonetti, 86; “mi’ padre, che·mmi tien sì magro, che tornare’ senza logro di Francia.”, Sonetti, 87); la moglie, antipatica e pettegola; l’amante, Becchina, con la quale ha un rapporto che oscilla tra la passione irrefrenabile e i violenti litigi («Becchin’ amor!» «Che vuo’, falso tradito?» / «Che·mmi perdoni». «[Tu] non ne se’ degno». / «Merzé, per Deo!» «Tu vien’ molto gecchito». / «E verrò sempre». «Che saràmi pegno?», Sonetti, 47. Qui addirittura viene ripreso il modello tradizionale del *contrasto nella forma del *sonetto, ed è particolarmente dissonante il linguaggio popolare di Becchina miscelato ai termini cortesi usati dal poeta, il tutto a fine comico).
Senza dubbio si è ben lontani da figure come l’integerrimo Dante e i suoi sobri componimenti narranti un romantico e casto amore, fatto appena di sguardi rubati, per l’eterea Beatrice; spesso infatti Cecco è stato definito l’antimodello di Dante, il suo amore per Becchina il rovesciamento dell’altro, persino Becchina stessa un’”anti-Beatrice”.
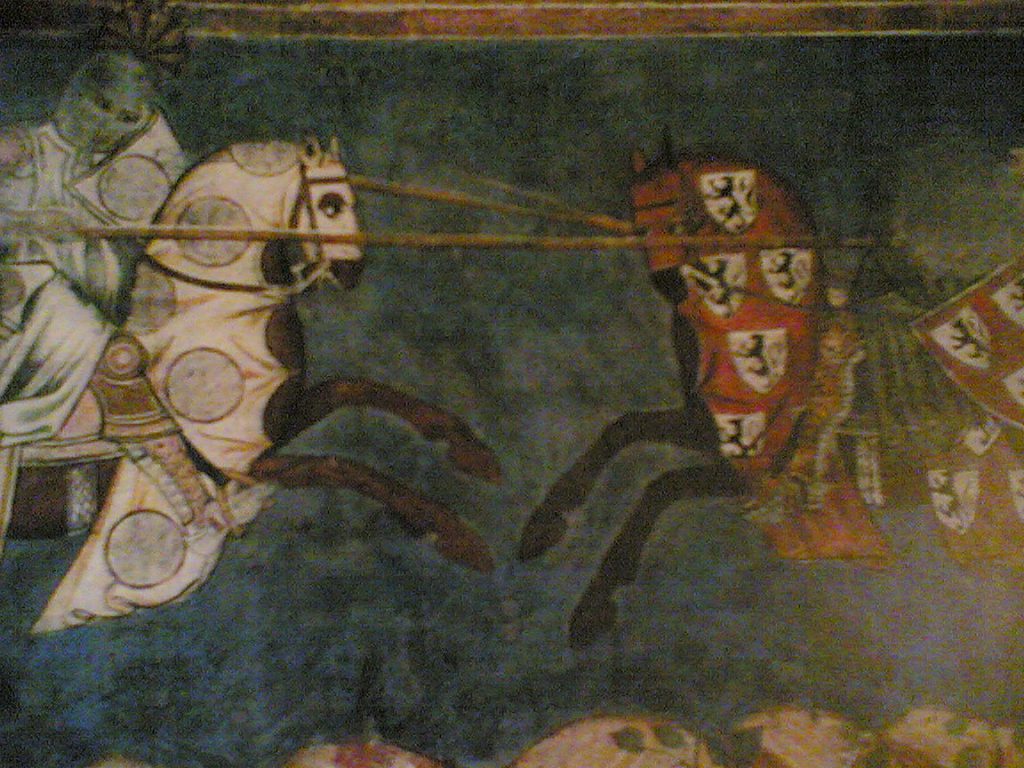
Sicuramente in molti suoi versi Angiolieri sembra duro, viziato, senza valori, aggressivo. Ma ciò su cui i critici moderni si sono soffermati e invitano a riflettere anche i comuni lettori è la natura dei componimenti del poeta e l’ideale poetico del quale sono portatori: il rovesciamento, appunto, del canone stilnovistico.
Ciò però non implica in alcun modo che il Cecco/personaggio che viene delineandosi nel Canzoniere corrisponda al Cecco/uomo, anzi. La visione “negativa” che il lettore odierno potrebbe avere di questo scrittore deriva dalla identificazione con la sua opera. E’ la lezione ottocentesca di poeta moderno, tormentato, che fa della sua opera una opera autobiografica: ma Angiolieri è un autore medievale, e come tale ha messo in opera una precisa costruzione letteraria, esagerando volutamente il tono popolaresco per scostarsi dall’altrettanto esagerata idealizzazione dell’arte che, a parere suo e degli altri comici, proponeva il coevo stilnovismo. Sicuramente alla creazione del Cecco/personaggio avranno contribuito vicende personali e ragioni ideologiche vere, ma queste sono sapientemente razionalizzate e utilizzate in modo colto e raffinato. Ecco cosa fa del Canzoniere un’opera di successo, che tiene tranquillamente testa alle opere della corrente poetica avversaria in retorica e stile e nella quale la borghesia cittadina si rivede e sa ridere di se stessa e dei propri vizi e difetti.

Fonti
La scrittura e l’interpretazione di Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese; Palermo, 2011
Dizionario Biografico degli Italiani, di Mario Marti, Volume 3; Roma, 1961.
Treccani, enciclopedia online sub voce Angiolièri, Cecco.
Enciclopedia Dantesca, di Mario Marti; Roma, 1970