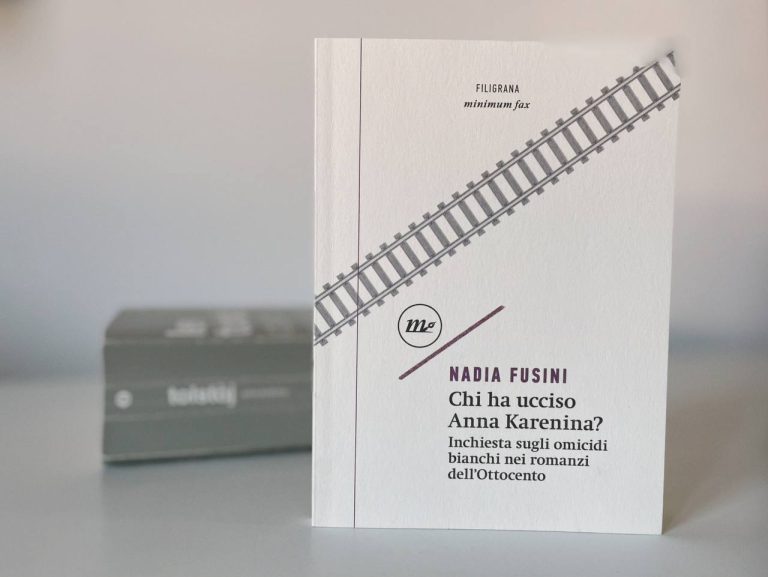Nadia Fusini, Chi ha ucciso Anna Karenina? | Il romanzo ottocentesco e le protagoniste di una libertà impossibile
Esiste un particolare piacere degli elenchi, dice Borges in Storia dell’eternità1, che nasce dal loro alludere all’eterno. Esiste sicuramente un’altra peculiare guisa del piacere letterario: i libri che parlano di altri libri. Questo è tanto più vero se l’oggetto d’analisi è “l’opera d’arte perfetta”, Anna Karenina, e la lente con cui la si osserva è quella di Nadia Fusini. In realtà, non è solo all’eroina di Tolstoj che Fusini guarda per compiere la sua Inchiesta sugli omicidi bianchi nei romanzi dell’Ottocento – come recita il sottotitolo di Chi ha ucciso Anna Karenina? – ma anche ad altre grandi protagoniste femminili della finzione letteraria di quegli anni, da Emma Bovary a Nora di Casa di bambola. Il tragico fallimento di ciascuna di queste eroine è la dimostrazione della grandezza di ognuna, ma soprattutto è una feroce denuncia sociale. In questo pamphlet, che l’autrice definisce “un vero e proprio processo contro il patriarcato”, si indaga per identificare, per queste morti, dei precisi colpevoli2. Ognuno di questi suicidi letterari è trattato piuttosto come un omicidio, un delitto in cui la mano dell’assassino è impalpabile nella corporeità, ma sensibile negli effetti, e perlopiù rivela i connotati della repressione patriarcale.
Se è vero che queste eroine sono giuste nell’obbedire a sé stesse, e se è vero che a tutte è riservato proprio per questo il ruolo di vittime della società, allora, inevitabilmente, è quella stessa società ad essere ingiusta. Un male sociale, dunque, quello che le condanna, una stretta maglia di ipocrisie macroscopiche e di strettoie morali. In questo quadro, Nadia Fusini tenta di mettere a fuoco volti e nomi, ritracciare i colpevoli. La sua indagine è travolgente, quasi come se di donne in carne ed ossa stesse parlando, e non di figure di carta. Ma che di Emma, di Anna, ne siano esistite davvero nessuno deve convincerci: Karenina, Bovary, e ognuna delle altre, c’est nous.

Il suicidio: prezzo dell’eversione e atto d’accusa
Pena per chi esce dai confini tracciati dal patto sociale è l’estromissione definitiva. Troppo, insomma, sarebbe stato, da parte dei romanzieri, non chiedere alle loro audaci protagoniste di congedarsi dal mondo.
“Il veleno del farmacista nel caso di Emma, le ruote del treno nel caso di Anna sono, sì, la giusta punizione – che loro stesse si danno – dell’atto eversivo che compiono. […] Quelle ruote, quel veleno sono senz’altro il prezzo che lo scrittore Flaubert, o lo scrittore Tolstoj, deve pagare all’ipocrita moralità del suo tempo…”3.
Chiara Mercuri ne parla nella sua monografia dedicata a Maria di Francia: lasciare un adulterio impunito era, per lo scrittore medievale, gesto tanto audace da sembrare inconcepibile. Chrétien de Troyes se ne vergognò a tal punto, sembra, da lasciare incompiuta l’opera, Lancillotto o il cavaliere della carretta, in cui i due amanti la fanno franca. Mercuri suggerisce che debba essere stata un’idea della rivoluzionaria committente, Maria. Ma, se Camaalot è un luogo irrintracciabile sulle mappe, una terra indefinita della fantasia in cui le regole sociali sembrano essere sospese, il romanzo ottocentesco dice, con verosimiglianza, la realtà del proprio tempo. E la sconfitta delle sue eroine è, prima di tutto, la condanna senza appello delle società in cui quelle si muovono, e trovano la morte. Il suicidio di Anna e delle altre denuncia l’impraticabilità di ogni via alternativa a quella pensata per loro dagli uomini, l’ingiustizia delle istituzioni – come il matrimonio – che esistono per “ostacolare la libertà femminile”4.
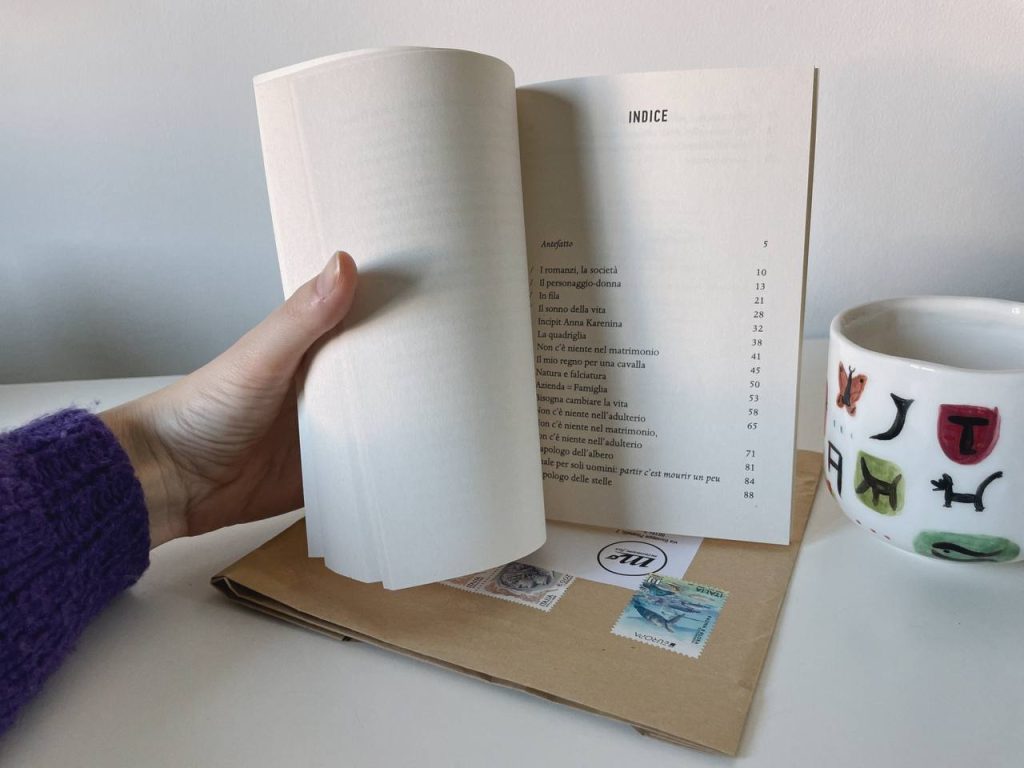
Donne perno della rivolta: una diversa idea di libertà
“Emma, Anna, Nora e le altre sono vittime senz’altro particolari: non si sono fatte massacrare senza parlare. Senza protestare. Senza raccontare quello spreco di vita di cui hanno dato comunque testimonianza. E lo spreco di vita è il peccato più grande”5.
Il suicidio, nelle storie di queste donne, ha rappresentato l’unica soluzione per sfuggire a una società che le aveva condannate per essere state presenti a sé stesse, per essere state vere. La loro morte è la spia “che smaschera la prepotenza del mondo maschile”6. La rivoluzione di queste protagoniste femminili parte dalla contestazione dello spazio sociale ad esse concesso. Primo tra tutti, quello del matrimonio. La leva con cui il romanziere ottocentesco critica le regole della realtà normativa, infatti, non è una donna qualunque, ma un’adultera. Un personaggio che “smaschera” con la sua stessa esistenza “l’irrealtà della realtà”7.
L’adultera, dice Fusini, “è il personaggio femminile che non si lascia più definire dal matrimonio”. Queste protagoniste, cioè, sono personaggi che non reprimono, non sacrificano, ma esprimono e finanche realizzano il proprio desiderio. Salvo poi scoprire, in tutti i casi, che l’adulterio è solo un altro calco dell’infelicità patriarcale, al pari del matrimonio da cui cercavano di evadere.
“Il matrimonio è un cenotafio dei sentimenti. E l’adulterio una falsa alternativa, perché ne ripete la struttura”8.
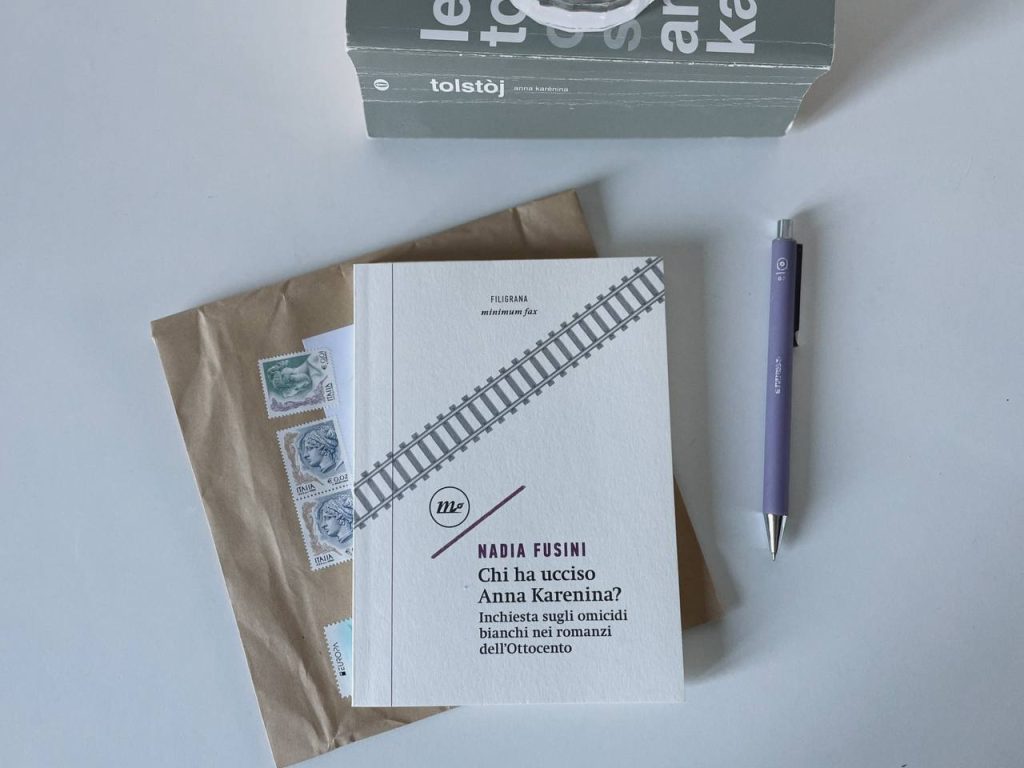
Essere sveglia: la consapevolezza di Anna come minaccia sociale
Anna Karenina, tra le protagoniste enumerate da Fusini, è prima per grado di consapevolezza della propria condizione. Ha capito che “il matrimonio non dà la felicità; e che altrettanto fallimentare è la sua replica, e cioè l’adulterio”9. Emma Bovary, diversamente da Anna, è inconsapevole della sua azione eroica, della sfida che lancia alla società, ma l’infelicità che finisce per sperimentare anche con l’adulterio le indicherà chiaramente che nulla permette di uscire ad una donna “dalla schiavitù delle leggi dell’uomo”. Ognuna di queste protagoniste, anche a partire da gradi di consapevolezza diversi, passa, per mezzo della propria morte bianca, dallo stato di sonno a quello di veglia, nel momento stesso in cui si rende conto che “gli uomini, proprio quelli che ama, la uccideranno”10. Lo stesso sperimenta, con loro, il lettore.

Lo stato di veglia di Anna attenta all’integrità dell’intero sistema patriarcale, in cui il sonno è la condizione naturale delle donne. Al centro di questo attacco, i capisaldi del sistema: il matrimonio, la famiglia. Quando Anna sceglie di amare Vronskij, la sua coscienza è vigile. L’espressione di questa libertà ha come diretta conseguenza l’espulsione di Anna dalla società. Ma le stesse conseguenze non intaccheranno il destino di Aleksej Vronskj che, anzi, ne uscirà rinvigorito:
“L’uomo può commettere adulterio, la donna no. E si delineano destini differenti: l’uomo si salva, la donna muore”11.
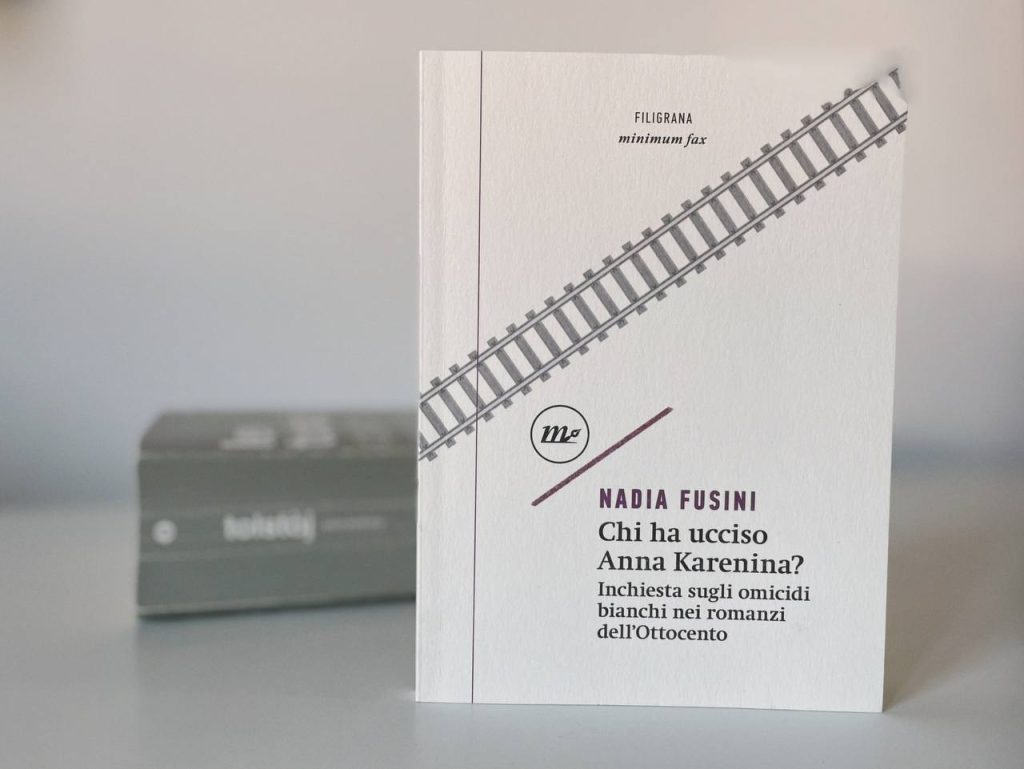
“Atroce destino che siano tutti e due Aleksej, non è vero?”
Amante e marito condividono lo stesso nome. Non è un caso. Nome è destino – e loro due, per Anna, si equivalgono, nel senso che nessuno dei due per lei può significare salvezza. Sono “eguali perché Anna si trova in loro potere”12. Alfine entrambi la deludono, il secondo tanto più crudelmente quanto più era creduto diverso dal primo. Entrambi la usano, il marito “per i suoi interessi di stabilità e perbenismo sociale”, e l’amante per alimentare la propria vanità, per “orgoglio del successo. Si vantava di lei”13. Ed è l’identificazione tra i due che, più eloquentemente di ogni altra cosa,
“vanifica l’idea romantico-convenzionale dell’adulterio come alternativa liberatoria rispetto al matrimonio”14.

Note:
1 Jorge Luis Borges, Storia dell’eternità, Adelphi, Milano, 2020, p. 32: “Lo stile del desiderio è l’eternità. (È verosimile che proprio nell’insinuazione dell’eterno – della immediata et lucida fruitio rerum infinitarum – risieda la causa del particolare piacere che provocano le enumerazioni).”
2 Nadia Fusini, Chi ha ucciso Anna Karenina? Inchiesta sugli omicidi bianchi nei romanzi dell’Ottocento, Minimum Fax, Roma, 2024, p. 34.
3 Ivi, p. 15.
4 Ivi, p. 102.
5 Ivi, p. 8.
6 Ibidem.
7 Ivi, p. 13.
8 Ivi, p. 44.
9 Ivi, p. 21.
10 Ivi, p. 26.
11 Ivi, p. 99.
12 Ivi, p. 69.
13 Ivi, p. 70.
14 Ivi, p. 71.
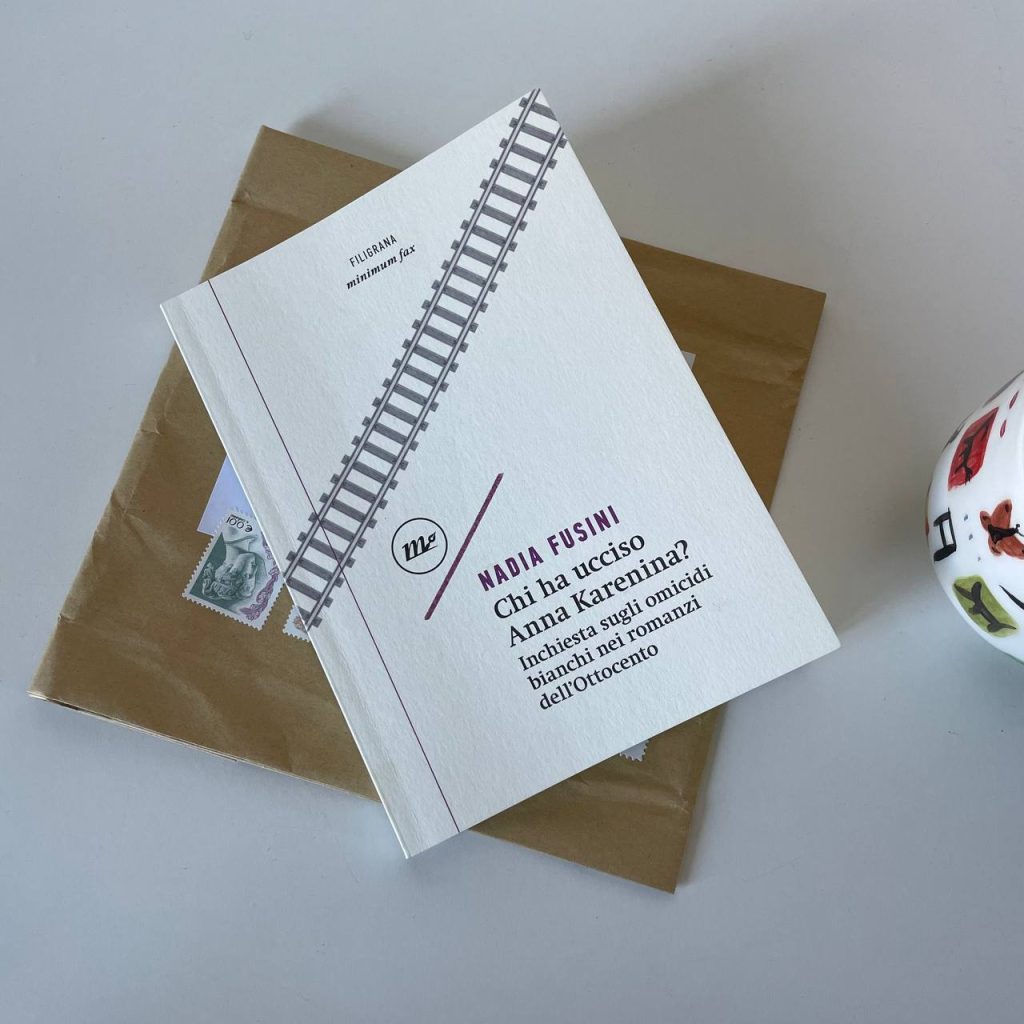
Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.