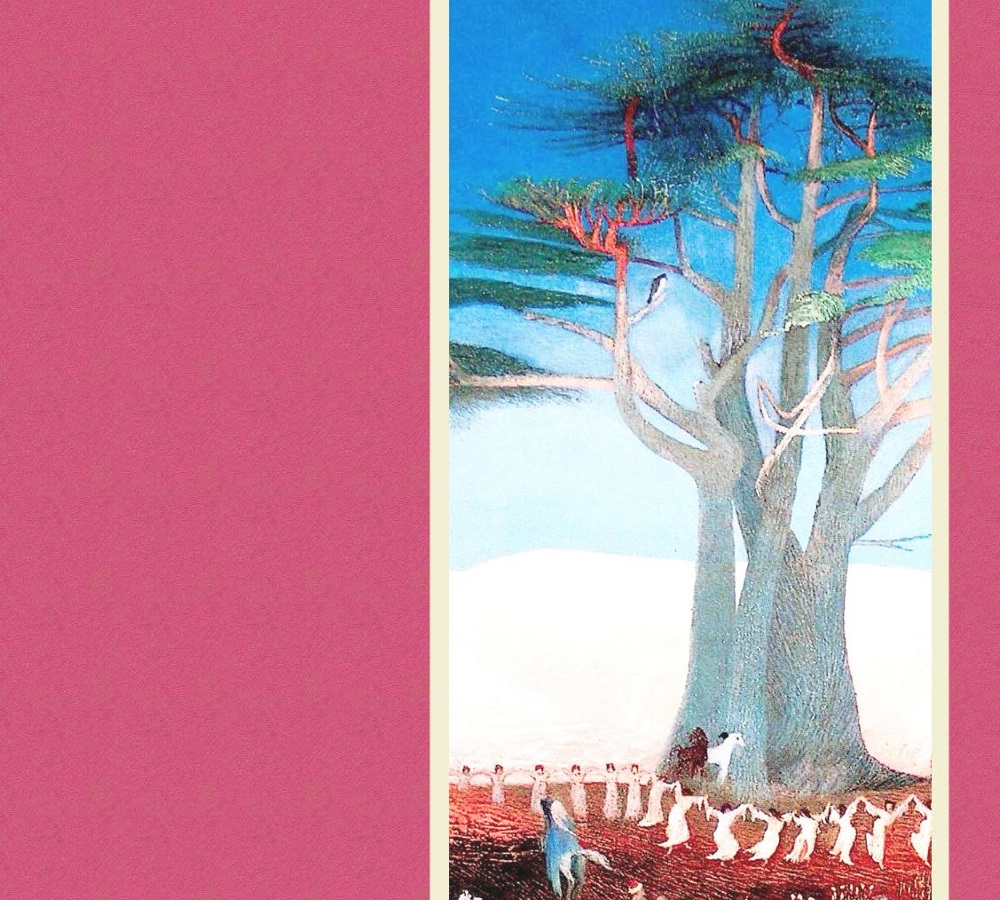Benedek Elek, C’era una volta o forse non c’era… Fiabe cosmologiche ungheresi, a cura di Elisa Zanchetta, Vocifuoriscena, Viterbo 2020
Presentazione del volume di Elisa Zanchetta (Università degli Studi di Padova)

C’era una volta o forse non c’era… Fiabe cosmologiche ungheresi propone la traduzione e l’analisi di quattordici fiabe popolari con testo ungherese a fronte, tratte dall’opera di Benedek Elek (1859-1929) intitolata Magyar mese- és mondavilág (“Mondo delle fiabe e delle leggende ungheresi”), pubblicata nel 1896 in occasione del Millennium, ovvero i mille anni di presenza degli ungheresi nel Bacino dei Carpazi.
C’era una volta o forse non c’era… è un titolo significativo per la presente raccolta, in quanto mira a un duplice obiettivo: da un lato proiettare immediatamente il lettore nella realtà altra in cui sono ambientate le fiabe ungheresi, dall’altro sensibilizzarlo alla formularità che le contraddistingue. Le fiabe proposte si svolgeranno, infatti, al di là dell’Óperenciás-tenger (“mare Óperencia”), abisso acqueo che potrebbe segnare il confine tra il mondo intermedio e l’aldilà; oppure al di qua o al di là di sette volte sette paesi, espressione contenente il riferimento al magico numero sette che, assieme ai suoi multipli, ricorre con insistenza nelle fiabe: sette dì e sette notti dura la scalata dell’égig érő fa (“albero che tocca il cielo”), sette sono le teste dello sárkány… oppure al di là degli Üveghegyek (“monti di vetro”) che si collocano sul bordo del mondo nel punto in cui la volta celeste è così bassa da impedire ai raggi solari di penetrare e da costringere le rondini a bere l’acqua in ginocchio. La formularità delle fiabe popolari ungheresi si discosta da quella che il lettore incontra approcciandosi ad altre narrazioni popolari europee: si tratta di formule riscontrabili nella tradizione caucasica e potrebbero pertanto essere considerate un retaggio culturale che gli antenati degli ungheresi portarono con sé durante la loro migrazione verso occidente.
Il sottotitolo Fiabe cosmologiche ungheresi chiarisce subito qual è il fil rouge che connette le quattordici fiabe selezionate, ovvero proporre al lettore italiano, sia esso uno specialista oppure un semplice appassionato, una carrellata di figure e luoghi della mitologia magiara. A prima vista gli ungheresi sembrano possedere un patrimonio mitologico assai scarso se paragonato a quello di voguli e ostiachi, popoli che, come l’ungherese, appartengono al supposto ramo linguistico ugrico. Il presente lavoro prende avvio dalla definizione di mitologia fornita dall’etnologo Hoppál Mihály, secondo cui la mitologia è quell’insieme di nozioni che possono essere ricostruite a partire dai canti popolari, dagli incantesimi e dalle fiabe: risulta quindi chiara l’importanza fondamentale che queste ultime acquisiscono per delineare la mitologia magiara. Nella traduzione tutti i termini riferiti alle figure e ai luoghi mitologici sono mantenuti in lingua originale, opportunamente tradotti e approfonditi nel saggio di apertura e nel glossario finale.
Il volume si apre con una fiaba che riprende una delle leggende relative all’origine di magiari e unni, condotti nella palude Meotide da un csodaszarvas, ovvero da un cervo meraviglioso, che nell’arte popolare sembra incarnare l’albero cosmico, in quanto raffigurato con corna simili a rami frondosi e con il corpo dritto e slanciato come il fusto di un albero che tocca il cielo.
Segue poi una carrellata di fiabe in cui vengono presentate le figure femminili della mitologia magiara, ovvero le tündérek, le fate, descritte sia come creature malevoli, sia benigne. Il lettore s’imbatterà dapprima nella vasorrú bába, la vecchia dal naso di ferro, «brutta come la disgrazia», come ben descritto nell’omonima fiaba. Vladimir Propp considera questa figura una versione magiara della baba jaga russa, ma potrebbe essere equiparata anche ai feticci utilizzati dai popoli ugrici per riconciliarsi con gli spiriti dei defunti: si trattava infatti di ceppi lignei conficcati nel suolo e ricoperti da uno strato di metallo per impedire che il sangue e la carne, con cui venivano spalmati, li facesse imputridire; il naso, invece, era sempre rappresentato da un chiodo. Le tündérek, ovvero le fate propriamente dette, vengono descritte come fanciulle «così abbaglianti che il sole lo si sarebbe potuto guardare, ma non loro», dai capelli dorati lunghi fino alle caviglie, abbigliate con vesti dorate e dotate della capacità di metamorfosarsi: facendo una capriola esse sono in grado di trasformarsi in colombe bianche oppure in cigni e in questa forma discendono sulla terra dove incontrano l’eroe di cui si invaghiscono. L’incontro avviene spesso sotto un melo oppure un pero carichi di frutti dorati, per poi proseguire nel Tündérország, il paese delle fate, dove flora e fauna sono dorate, nei corsi d’acqua guizzano pesci dorati, ci sono vasche dorate piene di latte in cui la tündérkirályné, ovvero la regina delle tündérek, fa quotidianamente il bagno. Talvolta l’eroe deve giungere autonomamente nel Tündérország dove la fata, in preda alla rabbia, è fuggita in seguito alla violazione di un divieto che aveva imposto all’amato: si tratta di un topos narrativo che richiama alla mente i racconti melusiniani. Il Paese delle fate dista, tuttavia, «più del cielo dalla terra», quindi l’eroe viene solitamente aiutato in quest’impresa da un griffmadár, un grifone che, trasportando i sacchi di farina alla regina delle tündérek, riesce ad accompagnarlo a destinazione.

Molto spesso la fata, oppure la figlia del re, viene rapita da un malevolo sárkány, sorta di drago contro cui l’eroe deve combattere. Si tratta di un mostro policefalo dotato di un’intelligenza malvagia, la cui forza è solitamente celata nella settima testa e la cui anima è ospitata nel corpo di un altro animale, risultando così lampante la credenza degli antichi ungheresi nella pluralità dell’anima: nella fiaba Az égig érő fa (“L’albero che tocca il cielo”) l’eroe, per annientare definitivamente lo sárkány, deve distruggere i nove calabroni che si trovano dentro una scatola contenuta nella testa della lepre che salterà fuori dalla testa di un cinghiale. Lo sárkány porta le fanciulle nel proprio palazzo di rame, d’argento, d’oro o di diamante, che spesso ruota vorticosamente sull’artiglio di un palmipede oppure sulla coda del gallo. Esso può essere situato nel mondo ctonio oppure sulla sommità dell’albero che tocca il cielo e solo l’eroe táltos, che nelle fiabe è il giovane pastore oppure porcaro dotato di capacità sciamaniche, è in grado di giungervi e di fermare la sua corsa. Il palazzo così descritto costituisce, assieme al vero e proprio égig érő fa, ovvero l’albero che tocca il cielo, una delle raffigurazioni dell’axis mundi magiaro.
Il termine táltos identificava anticamente il sacerdote degli ungheresi pagani; nel folklore e nelle fiabe popolari è colui che nasce con i denti, conosce tutto senza ricorrere allo studio, interpella i defunti per conoscere le cause della loro morte, sa rintracciare persone e animali scomparsi. Per giungere al palazzo dello sárkány posto nel mondo inferiore, o alsó világ, l’eroe táltos deve scendere attraverso un cunicolo che nelle fiabe viene indicato dal termine lik e che troverebbe corrispondenza con il “buco dello spirito” posto al centro del sole sui tamburi sciamanici sámi e con il lovi finlandese, ovvero la “fenditura rocciosa” attraverso cui si può giungere in una realtà altra. Per fare ritorno al mondo intermedio, o középső világ, il táltos viene aiutato da un’aquila gigante che, per riconoscenza, se lo carica sul dorso consegnandogli una bisaccia di provviste con l’ordine di allungargli un boccone ogni volta che glielo chiederà; esaurite le scorte, il giovanotto táltos taglierà un pezzo della propria coscia per permettere all’aquila di giungere in superficie, come ben descritto nella fiaba A táltos kecske (“La capra táltos”): in questo topos narrativo ravvisiamo la somiglianza con la variante cartvelica del mito di Amirani.
Se, invece, il palazzo si trova nel mondo superiore, ovvero nel felső világ, il táltos deve scalare l’égig érő fa, albero senza cima con rami sottili ma ricchi di foglie, tanto da essere equiparati a foreste, come descritto nell’opera di Diószegi Vilmos intitolata A pagány magyarok hitvilága (“Il mondo delle credenze degli ungheresi pagani”, 1967). Giunto sulla sommità dell’albero cosmico, il táltos entra in possesso della sua cavalcatura sciamanica rappresentata dal tátos ló, il cavallo tátos. Si tratta di un cavallo pelle e ossa, scabbioso, sciancato che sguazza nello sterco e che fa parte della mandria dello sárkány, della boszorkány, la strega del folklore magiaro, oppure della tündér. L’eroe deve servire il padrone del cavallo per un anno, che nelle fiabe corrisponde a un periodo di tre giorni, e chiedere questo ronzino come ricompensa per il suo operato. Solo con l’intervento dell’eroe táltos, il cavallo potrà divenire un destriero tátos dal manto dorato, con tre, cinque, nove zampe e in grado di solcare i cieli per portare l’eroe a combattere contro lo sárkány oppure altri táltosok. Il combattimento avviene solitamente assumendo la forma di tori neri e bianchi, ruote di ferro o fuoco, fiamme rosse o blu, come descritto nella fiaba A vörös tehén (“La mucca rossa”).
Con un balzo il cavallo tátos è in grado di giungere in mondi lontanissimi, ricordando, sotto questo aspetto, non solo il destriero di Óðinn, Sleipnir, ma anche Ṫeṫroni che conduce Amirani nel paese dei dèmoni-fabbri per cercare una fidanzata. Il tátos ló è un puledro curioso: si nutre di brace ardente come narrato nella fiaba Az égig érő fa (“L’albero che tocca il cielo”), può metamorfosarsi in altri animali che possono essere imbrigliati e domani solo dall’eroe, è dotato del dono della parola e sa volare per i cieli divenendo invisibile, pronunciando la formula «köd előttem s köd utánam» (“nebbia davanti a me e nebbia dietro di me”), comune anche alle tündérek. Talvolta si può ravvisare un rapporto quasi materno tra l’animale tátos e il táltos umano, in quanto quest’ultimo può addirittura nutrirsi del suo latte: significativo è infatti l’episodio descritto nella fiaba A vörös tehén (“La mucca rossa”) in cui la mucca invita il ragazzino a svitare una delle sue corna e a saziarsi di latte.

Concludiamo citando il peritesto di chiusura alla raccolta di Benedek Elek intitolato Itt a vége (“Questo è tutto”) in cui il raccoglitore non solo tira le fila del suo lavoro etnografico, ma pone anche enfasi sull’importanza di trasmettere le fiabe popolari ungheresi. Noi vorremmo che il lettore italiano percepisse che «il popolo ungherese ha riversato anche nelle fiabe le eccellenti caratteristiche che lo contraddistinguono da ogni altro popolo: la sua immaginazione coraggiosa […]; il suo umorismo inesauribile, le sue narrazioni geniali; il suo amore per il linguaggio costumato […]», ma che in un aspetto in particolare supera qualsiasi altro popolo, ovvero nella «rotondità compositiva delle fiabe», nella loro «perfezione artistica». Se Benedek è stato l’interprete dell’anima del popolo ungherese, come lui stesso adora definirsi, noi siamo onorati di esserne i traduttori. Ecco qui il libro: giudicate voi se abbiamo portato a termine quanto abbiamo intrapreso. E questo è tutto.